Nuove avventure sotterranee
Nuove avventure sotterranee
A Brief History of Photography in Six Images
An Essay by Alessandro Dandini de Sylva
Una breve storia della fotografia in sei immagini
Un testo di Alessandro Dandini de Sylva
The Pure Image
Domingo Milella and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
La pura immagine
Una conversazione tra Domingo Milella e Alessandro Dandini de Sylva
Faithful Accuracy
Luca Nostri and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Una fedele esattezza
Una conversazione tra Luca Nostri e Alessandro Dandini de Sylva
Nautilus
Giulia Parlato and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Nautilus
Una conversazione tra Giulia Parlato e Alessandro Dandini de Sylva
Brisbane Songlines
Rachele Maistrello and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Brisbane Songlines
Una conversazione tra Rachele Maistrello e Alessandro Dandini de Sylva
Canadiana
Stefano Graziani and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Canadiana
Una conversazione tra Stefano Graziani e Alessandro Dandini de Sylva
Di roccia, fuochi e avventure sotterranee
Di roccia, fuochi e avventure sotterranee
Building an Image
An Essay by Alessandro Dandini de Sylva
Costruire un’immagine
Un testo di Alessandro Dandini de Sylva
Conceptual Traces of Geology
Fabio Barile and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Le trame concettuali della geologia
Una conversazione tra Fabio Barile e Alessandro Dandini de Sylva
Many Fires Burn Below The Surface
Andrea Botto and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Molti fuochi ardono sotto il suolo
Una conversazione tra Andrea Botto e Alessandro Dandini de Sylva
Detour In Hanoi
Francesco Neri and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Detour In Hanoi
Una conversazione tra Francesco Neri e Alessandro Dandini de Sylva
Hippodamus
Marina Caneve and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Ippodamo
Una conversazione tra Marina Caneve e Alessandro Dandini de Sylva
Martian Chronicles
Alessandro Imbriaco and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Cronache marziane
Una conversazione tra Alessandro Imbriaco e Alessandro Dandini de Sylva
Middle-Earth. A journey Inside Elica
Middle-Earth. A journey Inside Elica
A Conversation
Fabio Barile, Francesco Neri and Alessandro Dandini de Sylva
Una conversazione
Fabio Barile, Francesco Neri e Alessandro Dandini de Sylva
An Essay by Alessandro Dandini de Sylva
Louis Daguerre did not invent photography. In 1839 there were many similar processes for recording and fixing photographic images, and there are many pioneers in the history of photography. Yet, our natural mechanism of understanding by simplification leads us to record only a few names and dates, a few well-aligned islands in the vast ocean of complexity. And the same is true for all the developments of the photographic language. We manage to associate certain names and dates with each season of the photographic medium and forget that culture and ideas evolve more as a constant flow of intuitions and imitations, things that become thinkable because they are suddenly technically possible, and incremental contributions from who knows how many authors buried in the folds of time.
However, if we happened to look at even the smallest part of what has remained hidden, we could find an unprecedented body of images in the photographic archive of a company like Ghella, which traces all phases of the history of photography, from the second half of the 19th century to the present day. We would come across new names and dates and glimpse unexpected geographies. The succession of canons of representation over time would seem more the result of the widespread sentiment of the different eras than the invention of individual creative geniuses. And if we were to attempt to superimpose Ghella’s visual memory on the chronology of the transformations of the photographic language, we could confuse the two narratives until making them coincide.
What follows is a brief history of photography in six images. It is the story of a company, a family and one of the greatest inventions of the 19th century.

1 — The Orientalists (or Francis Frith)
In 1839, the Commission des Monuments Historiques in France realized that the fledgling medium of photography could be put at the service of archaeological exploration. Indeed, travel studies, picturesque landscapes, ancient monuments and archaeological documents formed the basis for the first photo books. The imagery captured by photographers such as Maxime Du Camp, Francis Frith and Antonio Beato were exhibited in Europe as panoramas of a glorious journey from the heroic memories of antiquity to the astonishing accomplishments of technological progress. Orientalist painting lent photography its canons of visual representation, techniques for approaching the image and a wide array of subjects that had become emblematic of a new Grand Tour.

2 — The New Objectivity (or August Sander)
By the second half of the 19th century, it was already evident that photography could be used to gather knowledge and that photographic images were capable of accurately rendering reality, silencing the individual and momentary emotions that underpin every single glance. The idea of a great archive of the world suddenly seemed possible, for the mechanical eye and memory of the camera promised the absolute impartiality of the archivist. In Menschen des 20. Jahrhunderts, August Sander tasks the objective eye of the lens with capturing the numerous types of humanity that characterized early 20th-century German society, fusing the notion of classification and sociological knowledge in the photographic image.

3 — The Modern Era (or Lewis Hine)
With the advent of the 20th century, photography was put at the service of both industrial advertising and political propaganda. The age of the machine and the heroic worker of the 1930s, whose heyday could be seen in the Soviet Union in the work of Alexander Rodčenko and in Germany in that of Albert Renger-Patzsch, reached its culmination in the United States with the book that the Macmillan Company commissioned from Lewis Hine. In Men at Work: Photographic Studies of Modern Men and Machines, Hine photographed workers toiling on construction sites and railways, and in machine shops, blast furnaces and mines, documenting their interactions with machines in the modern world and celebrating their contribution to shaping progress.

4 — The Documentary Style (or Walker Evans)
From the mid-1930s, the ambiguity of the photographic document became the basis for a rethinking of photography. John Szarkowski offers a good description of it: “It was at this moment that sophisticated photographers discovered the poetic uses of bare-faced facts, presented with such fastidious reserve that the quality of the picture seemed identical to that of the subject. The new style came to be called documentary. This approach to photography was most clearly defined in the work of Walker Evans.” The neutrality and detachment of these photographers from the subject results in a portrayal capable of informing as well as reflecting on our perception of the world, accepting its underlying paradox. Suddenly documentary style and art – two hitherto irreconcilable extremes – ceased to rule each other out.

5 — New Topographics (or Lewis Baltz)
In the 1970s, the vast area of work of photographers who focused on documenting the changes taking place in the contemporary landscape, in the historical shift from industrial to post-industrial economy, took shape. In 1975, the exhibition New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape acknowledged that the formal and neutral detachment of the photographic document had the potential to revive our interpretative abilities, embraced the “documentary style” proposed by Walker Evans, and introduced a radical change from the traditional depiction of the landscape. Pictures of sublime natural panoramas gave way to unromantic visions of desolate industrial landscapes, suburban sprawl and everyday scenes.

6 — The Vernacular Style (or Stephen Shore)
The recognition of colour photography as an art form is the result of a process of aesthetic emancipation that commenced in the 1970s. The first artists to take colour beyond the domain of functional or vernacular photography – terms used to distinguish artistic photographs from commercial, scientific or amateur ones – included names such as William Eggleston and Stephen Shore. Their interest in ordinary architecture and mundane aspects of American popular culture, coupled with a vaguely diaristic approach and non-hierarchical framing of the image, produced an aesthetic of colour photography based on qualities that appear to contradict their claim to be art. The vernacular, adopted as both subject and style, became the means to deconstruct and renew the rules of the photographic language.
During the same period, continual technological improvements, combined with the growing use of electronics and automation, made cameras increasingly easy to use and turned the photographer’s trade into a job accessible to everyone. The task of documenting the progress of the construction sites of companies such as Ghella started to be entrusted to anyone on site with a camera. Engineers, architects and technicians of various kinds helped to shape a new imagery of the construction site with their involuntary aesthetics. Vernacular photography – the kind without any artistic intentions, depicting ordinary events and everyday family life – entered the vocabulary of industrial photography.
Nuove avventure sotterranee (“New Underground Adventures”) brings together a selection of 32 colour images documenting infrastructures built by Ghella between the late 1960s and early 2000s (before digital photography became accessible to the general public) with the new photographic campaigns commissioned by the company between 2022 and 2023 at construction sites in Auckland, Brisbane, Buenos Aires, Naples and Vancouver.
The difference between the two groups of photographs lies in the language. The archive photographs collected in this book, shot on 35 mm film, grainy and often illuminated by artificial lights, depict the everyday life of the construction site and appear as a haphazard collection of ordinary moments, an accumulation of fragments that reflect the experience of seeing in an unfiltered manner. By contrast, the new photographic campaigns by Stefano Graziani, Rachele Maistrello, Domingo Milella, Luca Nostri and Giulia Parlato explore the same world but with greater awareness. On the one hand, due to the large amount of information condensed in each frame, on the other, thanks to each photographer’s ability to project the atmosphere of the construction site onto their personal work in an extraordinarily consistent way.
Observing the construction sites is just the starting point for a series of reflections on the clichés of depiction and the ambiguity of the photographic document, on excavation as a dreamlike interpretation of the intangible aspects of the landscape, on the symbolism of the cave and abstraction, and on the flow of the river and the depths of the sea as renderings of the city’s nature, shape and emergencies. All these factors turn their work into a contemplation of the meaning of images, reminding us once again that a photograph can be a document and an act of the imagination, a record and a possibility, all at the same time.
Un testo di Alessandro Dandini de Sylva
Louis Daguerre non ha inventato la fotografia. Nel 1839 esistevano molti processi simili per registrare e fissare le immagini fotografiche e nella storia della fotografia esistono diversi pionieri. Eppure, il meccanismo di semplificazione che ci è connaturato ci porta a registrare solo alcuni nomi e alcune date, poche isole ben allineate nel vasto oceano della complessità. E lo stesso vale per le evoluzioni del linguaggio fotografico: riusciamo ad associare alcuni nomi e alcune date ad ogni stagione del mezzo fotografico e dimentichiamo che la cultura e le idee evolvono più come un flusso continuo di intuizioni e imitazioni, di cose che diventano pensabili perché improvvisamente sono tecnicamente possibili e di contributi incrementali di chissà quanti autori sommersi nelle pieghe del tempo.
Ma se ci capitasse di osservare anche una minima parte di ciò che è rimasto nascosto, potremmo scoprire nell’archivio fotografico di un’azienda come Ghella un inedito corpus di immagini che attraversa tutte le fasi della storia della fotografia, dalla seconda metà del XIX secolo fino ai nostri giorni. Incontreremmo nuovi nomi e nuove date e scorgeremmo inaspettate geografie. I canoni di rappresentazione che si sono succeduti nel tempo ci sembrerebbero più il risultato del sentire diffuso delle diverse epoche che l’invenzione di singoli geni creativi. E se tentassimo di sovrapporre la memoria visiva di Ghella alla cronologia delle trasformazioni del linguaggio fotografico, potremmo confondere le due narrazioni fino a farle coincidere.
Quella che segue è una breve storia della fotografia in sei immagini. È la storia di un’azienda, di una famiglia e di una tra le più grandi invenzioni del XIX secolo.

1 — Gli Orientalisti (o Francis Frith)
Nel 1839, in Francia, la Commission des Monuments Historiques riconosce che la neonata fotografia può essere messa al servizio dell’esplorazione archeologica. Studi di viaggio, paesaggi pittoreschi, monumenti antichi e documenti archeologici costituiscono la base dei primi libri fotografici. L’immaginario catturato da fotografi come Maxime Du Camp, Francis Frith e Antonio Beato viene mostrato in Europa come il panorama di un glorioso viaggio dalle memorie eroiche dell’antichità fino ai successi strabilianti del progresso tecnologico. La fotografia acquisisce dalla pittura orientalista codici di rappresentazione, tecniche di approccio all’immagine e un gran numero di soggetti divenuti emblematici di un nuovo Grand Tour.

2 — La Nuova Oggettività (o August Sander)
Già dalla seconda metà del XIX secolo, si comprende che la fotografia può svolgere un compito di natura conoscitiva e che le immagini fotografiche sono in grado di restituire la realtà nella sua esattezza, tacitando le emozioni individuali e momentanee che sorreggono ogni singolo sguardo. L’idea di un grande archivio del mondo sembra improvvisamente possibile perché l’occhio e la memoria meccanica della macchina fotografica promettono l’assoluta imparzialità dell’archivista. August Sander, in Menschen des 20. Jahrhunderts, affida allo sguardo oggettivo dell’obiettivo il compito di rilevare i molteplici tipi di umanità che caratterizzano la società tedesca di inizio Novecento, sintetizzando nell’immagine fotografica l’idea della classificazione e della conoscenza sociologica.

3 — L’epoca moderna (o Lewis Hine)
Con l’avvento del XX secolo, la fotografia viene messa al servizio tanto della pubblicità industriale quanto della propaganda politica. L’età della macchina e del lavoratore eroico degli anni Trenta, che vede la sua apoteosi in Unione Sovietica nel lavoro di Alexander Rodčenko e in Germania in quello di Albert Renger-Patzsch, culmina negli Stati Uniti con il libro commissionato a Lewis Hine dalla Macmillan Company. In Men at Work: Photographic Studies of Modern Men and Machines, Hine fotografa operai al lavoro in officine meccaniche, cantieri di costruzioni, altiforni, ferrovie e miniere, documentando l’interazione del lavoratore con le macchine nel mondo moderno e celebrando il loro contributo alla costruzione del progresso.

4 — Lo stile documentario (o Walker Evans)
Dalla metà degli anni Trenta, l’ambiguità del documento fotografico viene posta come base per un ripensamento della fotografia. John Szarkowski ne dà una buona descrizione: “In quel periodo alcuni fotografi raffinati scoprirono l’uso poetico dei fatti guardati in modo diretto, presentati con un distacco tale che la qualità dell’immagine sembrava identica a quella del soggetto fotografato. Questo nuovo stile si fece chiamare documentario, e si è definito nel modo più chiaro nell’opera di Walker Evans”. La neutralità e il distacco di questi autori dal soggetto produce una rappresentazione capace di informare, come pure di riflettere sulla nostra percezione del mondo, accettandone il paradosso di fondo. A un tratto stile documentario e arte, due poli fino ad allora inconciliabili, smettono di escludersi.

5 — Nuovi topografici (o Lewis Baltz)
Negli anni Settanta, prende forma la vasta area di lavoro dei fotografi che si dedicano allo studio dei mutamenti in corso nel paesaggio contemporaneo, nel passaggio storico dall’economia industriale a quella post-industriale. Nel 1975, la mostra New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape riconosce al distacco formale e neutrale del documento fotografico la potenzialità di rigenerare le nostre capacità di lettura, fa suo lo stile documentario proposto da Walker Evans e introduce un cambiamento radicale rispetto alla tradizionale rappresentazione del paesaggio. Le immagini di sublimi panorami naturali lasciano il posto a visioni non romantiche di desolati paesaggi industriali, espansioni suburbane e scene quotidiane.

6 — Lo stile vernacolare (o Stephen Shore)
Il riconoscimento della fotografia a colori come forma d’arte è il risultato di un processo di emancipazione estetica iniziato negli anni Settanta. I primi artisti a portare il colore oltre il dominio della fotografia funzionale o vernacolare – termini utilizzati per distinguere le fotografie artistiche da quelle commerciali, scientifiche o amatoriali – sono autori come William Eggleston e Stephen Shore. Il loro interesse per l’architettura ordinaria e per gli aspetti banali della cultura popolare americana, insieme all’approccio vagamente diaristico e all’inquadratura non gerarchica dell’immagine, produce un’estetica della fotografia a colori a partire da qualità che sembrano contraddire la loro pretesa di essere arte. Il vernacolare, assunto sia come soggetto sia come stile, diventa il mezzo per decostruire e rinnovare le regole del linguaggio fotografico.
In quegli stessi anni, il continuo miglioramento della tecnologia, così come il sempre maggiore ricorso all’elettronica e all’automazione, rendono le fotocamere sempre più semplici da usare e trasformano il mestiere del fotografo in un lavoro alla portata di tutti. La documentazione degli stati di avanzamento dei cantieri di un’azienda come Ghella inizia a essere affidata a chiunque si trovi sul posto con una macchina fotografica. Ingegneri, architetti e tecnici di vario genere contribuiscono con la loro estetica involontaria a dar forma a un nuovo immaginario del cantiere. La fotografia vernacolare, quella priva di intenzione artistica, quella degli avvenimenti ordinari e della quotidianità in famiglia, entra nel vocabolario della fotografia industriale.
Nuove avventure sotterranee mette in dialogo una selezione di trentadue immagini a colori che documentano infrastrutture realizzate da Ghella tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Duemila (prima che la fotografia digitale divenisse accessibile al grande pubblico) con le nuove campagne fotografiche commissionate dall’azienda tra il 2022 e il 2023 nei cantieri di Auckland, Brisbane, Buenos Aires, Napoli e Vancouver.
La differenza tra i due corpus fotografici sta nel linguaggio. Le fotografie d’archivio raccolte in questo libro, scattate in 35 mm, granulose e spesso illuminate da luci artificiali, rappresentano la quotidianità del cantiere e si presentano come una raccolta disordinata di momenti qualsiasi, un accumulo di frammenti che riflettono in modo non filtrato l’esperienza del vedere. Al contrario, le nuove campagne fotografiche, realizzate da Stefano Graziani, Rachele Maistrello, Domingo Milella, Luca Nostri e Giulia Parlato, esplorano lo stesso mondo, ma con una consapevolezza aumentata. Da un lato, per la grande quantità di informazioni condensate in ogni fotogramma; dall’altro, per la capacità di ogni autore di proiettare l’atmosfera del cantiere nelle rispettive ricerche personali in modo straordinariamente organico.
L’osservazione dei cantieri è solo il punto di partenza per una serie di riflessioni sui cliché della rappresentazione e sull’ambiguità del documento fotografico, sullo scavo come lettura onirica degli aspetti intangibili del paesaggio, sul simbolismo della caverna e sull’astrazione, sullo scorrere del fiume e sulle profondità del mare come restituzioni del carattere, della forma e delle emergenze della città. Tutti questi fattori trasformano il loro lavoro in una meditazione sul senso delle immagini e ci ricordano, ancora una volta, che una fotografia può essere un documento e un atto dell’immaginazione, una registrazione e una possibilità, tutto nello stesso tempo.
Domingo Milella and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
In the necropolises of Tuscia, in the rock-hewn churches in Cappadocia, and, many years earlier, in Lascaux, I saw that there is a direct link between the cave and the spirit, as strong as that which connects the sky and the mind.1
AD: The few lines that we’ve chosen as an introduction to our conversation trace a path that sums up your line of artistic enquiry over the past twenty years with that simplicity and clarity that fill us with awe whenever we encounter our own thoughts in the words of others.
DM: I’ve been working with caves and prehistoric art for eight years. So I already had this relationship with caves and the primitive, the imagery of excavation, emptiness and darkness, before I even entered the CFT. This meant I felt at home at the consortium’s construction sites. Agamben’s words seem to look back to my past; I’ve worked extensively in Anatolia, Cappadocia, archaic Egyptian tombs, and the buried landscapes of the fringes of Aztec Mexico. I started my journey by learning to use a 20×25 view camera in the parking lots of New York’s Lower East Side in the early 2000s, but subsequently I’ve always sought something original, fresh, a first. In my final year at the School of Visual Arts I decided to skip all the Photoshop courses, devoting myself instead to colour printing in the darkroom. The transition from the colour darkroom on Manhattan’s 22nd Street to Europe’s historiated caves isn’t something that surprises me today, looking back twenty years; we all have a latent image within us, which takes its time to develop.
AD: From the caves that have preserved the oldest human traces on Earth in darkness for thousands of years to the tunnels of the new Naples-Bari high-speed railway line, which has opened underground passages in the landscape to bring contemporary humans closer to the future.
DM: The thing that strikes me most about the tunnels is the sound of the construction site, the echo of work, the undercurrent of time, of digging through time. In some of the pictures I tried to portray this sense of the depth and curvature of space and time that the tunnel conveyed. This stage of excavating the mountain, of crossing it to alter space-time, is perhaps the essence of my work, something that sucks you in and suddenly transports you far away to an unpredictable elsewhere at a crazy speed. I’ve seen the digging, the dust, the work and the sound as this collective ambition to cross the uncrossable; that’s what these tunnels do, remove us from the name, the present, the place. In the end I always arrive at abstraction.
AD: The work collected in this book runs right through your entire imagery. In your photographs of the construction site, I saw the Hartapu monument in Kızıldağ again, the engraving of the auroch in Papasidero, the wall of the cemetery in San Giovanni Galermo and the graffiti-covered wall in Milan.
DM: I tried to make a personal work, as an artist, with the photograph itself reflected in time, curving round until its ends meet and disappearing into the concave space. That’s why clues are crucial in this puzzle, clues as images, keys to my journey – not my photographs, but the images that made them possible. There are basically two of them, then a third image, essentially forming a triangle. In May 2022, I wanted to visit the city of Benevento with my girlfriend Francesca before returning to the tunnels. I thought it was important to see the oldest city near the construction sites. Caught in a sudden downpour, we took shelter under Trajan’s Arch in the city centre. While we were under the arch, I discovered a strange, faint engraving of a horse, which was very delicate and beautiful, and I decided to photograph it with the big view camera – the camera was bigger than the drawing itself. It was undoubtedly an historical engraving, from perhaps 100, 200, 300 or even 1,000 years ago, who knows? But never mind its archaeological value, let’s return to the pure image: an arch that creates an imaginary bridge, in which, in its innermost part, there resides an animal, a Spiritus Rector, a guardian of the arch or, as they say in Ghostbusters, a gatekeeper. It was perhaps only a year later, towards the end of my visits to the CFT, that I discovered that there’s a rampant horse on all the workers’ placemats in the canteen. Actually, it’s much more than a horse, it’s the skeleton of a rampant horse. Perhaps it’s the protective spirit of the tunnel, the workers and the construction site that tries to pierce space and time like my photographs? A rampant horse also adorns the cutlery holder, containing the utensils to feed the consortium’s entire workforce; it’s dead – a skeleton – but it always resurrects, at lunch and dinner each day. We are left with the simple truth of the image: a horse that comes to life and bolts from the world of the dead, from the underworld to us. I’d seen a similar horse in Harry Potter, and it was also winged! It was invisible to everyone except Harry and his friend Luna, endowed with a strange ability to see ghosts, just like Harry, who was also initiated into mysteries that are forbidden to us. In between visits to the CFT, I also happened to have the good fortune to return to a cave I know very well, at Monte Castillo in northern Spain. It’s a triangular mountain that’s home to numerous caves, engravings, drawings and depictions of the earliest images in human history. I had been to Monte Castillo many times, but on this visit accompanied by Eduardo and Francesca we reached the point in the cave where I was convinced it ended. It’s a special, very deep place, where the stalactites and stalagmites are almost completely soaked in red ochre and where it really seems you can’t go any further beyond a precipice and a ditch. However, that day I discovered that there’s a little path that goes a few dozen metres further, and that it’s not the end of the cave; the end isn’t the real end. I also discovered that there are small carvings on the floor like nowhere else in the cave, a drawing of a pair of horses, and a lone horse at the end of the space, at the end of time.
AD: Reflection on the depiction of the construction site gradually overlapped with reflection on photography. To use Agamben’s words, that direct link that mysteriously connects the cave to the spirit, and the sky to the mind, led you from the symbolism of the cave to pure abstraction. A transition that’s also marked by the use of your phone camera as a visual notebook. It’s probably a kind of liberation after all these years in the darkness of the darkroom.
DM: Working in the darkness of caves so close to 40,000-year-old drawings has certainly changed something inside me. The complete lack of movement, the compression and the difficulties of the view camera that I’d imposed on myself in the caves, made my language abstract. The prehistoric experience liberated me from myself, putting me in touch with a bigger picture. I have hundreds of photographs taken with my iPhone that don’t depict anything… or so it would seem. In a way, they gathered themselves, as preparatory images of a highly imaginative organism. It all happened listening to music and walking in the contemporary world with the prehistoric images still in my heart. I asked myself what the future image might be? The deep past prompted me to imagine our future. I started to make room for simple signs and colours, lines and flashes on walls, surfaces, doors, boundaries of many realities. I see many of these files as “preparatory drawings”, like a game. Photography can be drawing, it can be painting, it can be what it is: Pure Image.
AD: Beneath the artificial light of the tunnel, you managed to connect two seemingly distant sides of photography: documentation on the one hand and abstraction on the other.
DM: Everything is curved and connected by a tunnel that, like a circle, reminds us that we live on the surface of a burning sphere, covered with water and earth, which floats in the darkness and moves in the light.
1 Giorgio Agamben, Quel che ho visto, udito, appreso… (Turin: Einaudi, 2022).
Una conversazione tra Domingo Milella e Alessandro Dandini de Sylva
Nelle necropoli della Tuscia, nelle chiese scavate nella roccia in Cappadocia e, molti anni prima, a Lascaux ho visto che fra la caverna e lo spirito vi è un nesso immediato, altrettanto forte di quello che unisce il cielo alla mente.1
AD: Le poche righe che abbiamo scelto come introduzione alla nostra conversazione tracciano una parabola che sintetizza la tua ricerca artistica negli ultimi venti’anni con quella semplicità e quella chiarezza che ci riempiono di stupore ogni volta che incontriamo i nostri pensieri nelle parole di altri.
DM: Sono otto anni che mi occupo di caverne e arte preistorica. Quindi questo rapporto con la grotta e con il primitivo, l’immaginario dello scavo, del vuoto e del buio, mi apparteneva già prima di entrare al CFT. Nei cantieri del consorzio mi sono quindi sentito a casa. Le parole di Agamben sono retro-veggenti a modo loro; ho lavorato molto in Anatolia, in Cappadocia, nelle tombe dell’Egitto arcaico, nei paesaggi sepolti delle periferie del Messico Azteco. Ho iniziato il mio viaggio imparando a usare il banco ottico 20×25 nei parcheggi del Lower East Side a New York nei primi anni Duemila, ma poi ho sempre cercato qualcosa di originario, di primo, di sorgivo. Decisi nel mio ultimo anno alla School of Visual Arts di saltare tutti i corsi di Photoshop e d’immergermi invece nella stampa a colori in camera oscura. Il passaggio dalla “color dark-room” sulla ventiduesima strada a Manhattan alle grotte istoriate d’Europa non è una cosa che oggi, ripensando a vent’anni fa, mi sorprende; tutti abbiamo un’immagine latente dentro di noi, che richiede il suo tempo per svilupparsi.
AD: Dalle caverne che hanno custodito per migliaia di anni nell’oscurità le più antiche tracce dell’uomo sulla Terra ai tunnel della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, che aprendo varchi sotterranei nel paesaggio, avvicinano l’uomo di oggi al futuro.
DM: La cosa che mi colpisce di più dei tunnel è il suono del cantiere, l’eco del lavoro, il sottofondo del tempo, dello scavo nel tempo. In alcune immagini ho provato a ritrarre questo senso del profondo e della curvatura dello spazio e del tempo che la galleria trasmetteva. Questo stadio dello scavare la montagna, di attraversarla per modificare lo spazio-tempo, forse è il nocciolo del mio lavoro, qualcosa che ti risucchia e improvvisamente ti trasporta lontanissimo e in un’imprevedibile altrove a una velocità senza senso. Ho visto lo scavo, la polvere, il lavoro e il suono come questa collettiva ambizione di travalicare l’intravalicabile… magari è una parola che non esiste neanche, ecco cosa fanno questi tunnel: portano fuori dal nome, dal presente, dal dove. Alla fine approdo sempre all’astrazione, che mi sono spesso domandato, è azione delle stelle?!
AD: Il lavoro raccolto in questo libro ripercorre trasversalmente tutto il tuo immaginario. Nelle tue fotografie del cantiere ho rivisto il monumento di Hartapu a Kızıldağ e l’incisione del Bove Primigenio di Papasidero, ho rivisto il muro di cinta del cimitero di San Giovanni Galermo e la parete ricoperta di graffiti a Milano.
DM: Ho provato a fare un lavoro personale, come artista, che con la fotografia si riflettesse nel tempo curvandosi sino a fermarsi su sé stesso e a scomparire nello spazio concavo. Per questo sono cruciali gli indizi in questo enigma, indizi come immagini, chiavi del mio viaggio – non le mie fotografie, ma le immagini che le hanno rese possibili. Sono essenzialmente due, poi una terza immagine, a formare fondamentalmente un triangolo. A Maggio del 2022 prima di tornare nei tunnel ho voluto visitare con la mia fidanzata Francesca la città di Benevento. Trovavo fosse importante vedere il centro più antico vicino ai cantieri. A causa di una grande pioggia improvvisa ci siamo riparati sotto l’arco di Traiano che si trova al centro della cittadina. Mentre eravamo lì sotto ho scoperto una strana e pallida incisione di un cavallo, molto bella, molto leggera, ed ho deciso di fotografarla con il grande banco ottico – la macchina fotografica era più grande del disegno stesso. Un’incisione storica certo, di forse 100, 200, 300 o anche 1.000 anni fa, chi lo sa? Ma non importa il suo valore archeologico, torniamo all’immagine pura: un arco che crea un ponte immaginario, dentro il quale, parte più intima, risiede un animale, uno Spiritus Rector, un guardiano dell’arco, o come dicono in Ghostbuster, un guardiano di porta… Forse solo un anno dopo, verso la fine delle mie visite al CFT scopro che sulla tovaglietta della mensa di tutti i lavoratori è impresso un cavallo – rampante. Per essere esatti, è molto di più di un cavallo: è lo scheletro di un cavallo rampante. Forse l’anima protettrice del tunnel, dei lavoratori e del cantiere che tenta, come le mie fotografie, di perforare lo spazio e il tempo? Un cavallo rampante adorna anche il contenitore delle posate, strumenti per la nutrizione di tutta la manodopera del consorzio; è morto, è uno scheletro, ma risuscita sempre, ogni giorno, a pranzo e a cena. Rimaniamo con la semplice verità dell’immagine: è un cavallo che giunge vivo e imbizzarrito dal mondo dei morti, dal sottomondo a noi. Avevo visto un cavallo simile in Harry Potter, peraltro era alato! Era invisibile a tutti, tranne ad Harry e alla sua amica Luna, anch’essa dotata di una strana capacità di vedere i fantasmi, proprio come Harry, iniziato anche lui a Misteri a noi preclusi. Tra una visita e l’altra al CFT mi capita di avere la fortuna di tornare in una grotta che conosco molto bene, al monte Castillo nel nord della Spagna. Una montagna triangolare che contiene numerose grotte, incisioni, disegni e rappresentazioni delle prime immagini della storia dell’uomo. Ero stato tante volte al Castillo, ma in occasione di questa visita in compagnia di Eduardo e Francesca arriviamo nel punto in cui ero convinto che la caverna finisse. È un luogo particolare, molto profondo, dove le stalattiti e le stalagmiti sono quasi completamente imbevute di ocra rossa e dove oltre un dirupo e un fosso sembra davvero non si possa andare avanti. Invece scopro quel giorno che esiste un piccolo sentiero che prosegue per altre decine di metri e che la fine della caverna non è quella; la fine non è la vera fine. Scopro inoltre che come in nessun’altra parte della grotta, esistono delle piccole incisioni sul pavimento: un disegno di una coppia di cavalli – e un cavallo solitario al fondo dello spazio, al fondo del tempo.
AD: La riflessione sulla rappresentazione del cantiere si è progressivamente sovrapposta alla riflessione sulla fotografia. Per dirla con le parole di Agamben, quel nesso immediato che misteriosamente unisce la caverna allo spirito e il cielo alla mente ti ha condotto dal simbolismo della grotta alla pura astrazione. Un passaggio segnato anche dall’uso della fotocamera del telefono come quaderno di appunti visivi. Probabilmente una sorta di liberazione dopo tutti questi anni nell’oscurità della camera oscura.
DM: Sicuramente l’aver lavorato nel buio delle grotte così vicino a disegni di 40.000 anni fa, ha cambiato qualcosa dentro di me. La totale mancanza di movimento, la compressione e le difficoltà del banco ottico che mi ero imposto di usare nelle caverne, hanno reso astratto il mio linguaggio. L’esperienza preistorica mi ha liberato da me stesso, mettendomi in contatto con un disegno più grande. Ho centinaia di fotografie fatte con l’iPhone che non ritraggono nulla… o almeno così sembrerebbe. In un certo senso, si sono raccolte da sole, come immagini preparatorie di un organismo immaginifico. Tutto è avvenuto ascoltando la musica e camminando nel mondo contemporaneo con ancora le immagini preistoriche nel cuore. Mi domandavo: quale potrebbe essere l’immagine futura? Il profondo passato mi ha spinto a immaginare il nostro avvenire. Ho cominciato a dare spazio a semplici segni e colori, linee e bagliori su muri, superfici, porte, confini di tante realtà. Molti di questi file li vedo come “disegni preparatori”. La Fotografia può essere disegno, può essere dipinto, può essere quel che è: Immagine Pura.
AD: Sotto la luce artificiale del tunnel, sei riuscito a collegare due versanti apparentemente lontani della fotografia: da un lato la documentazione e dall’altro l’astrazione.
DM: Tutto è curvo e collegato da un tunnel che, come un cerchio, ci ricorda che viviamo sulla superficie di una sfera rovente, coperta di acqua e terra, che fluttua nel buio e si muove nella luce.
1 Giorgio Agamben, Quel che ho visto, udito, appreso…, Einaudi, Torino 2022.
Luca Nostri and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: Unlike the construction sites visited by the other authors featured in this collection, work on the Matanza-Riachuelo Basin, one of the most complex wastewater purification projects in the world, was almost finished when you arrived in Buenos Aires. The new network of tunnels had been completed and the main wells were about to be sealed. Travelling along the banks of the Rio Matanza-Riachuelo to its mouth in the Rio de la Plata, between the barrio of La Boca and the town of Dock Sud, was the only way to “see” the invisible infrastructure that will improve the quality of life of over 14 million people in the coming years.
LN: When I was assigned the Buenos Aires construction site, I was immediately struck by the imagery of the Riachuelo River, which runs through the city and flows into the Rio de La Plata, opposite Uruguay, and which is unfortunately mainly known for its pollution and associated problems, with serious consequences for the inhabitants of some of the city’s critical districts. I have always been interested in the geographical and topographical exploration of an area, which limits my work but also helps to guide it, and is usually a good excuse to go out and take photographs. With this in mind, I started by looking back over some books, including The Red River by Jem Southam, who was my tutor at Plymouth for my PhD. Although The Red River is set in a rural area, there are many similarities in the sequence of 50 photographs following a watercourse in west Cornwall, from source to sea, which passes through different areas. The entire river valley has been extensively mined for tin and copper ore for hundreds of years, and it is the extraction of water from the mine and its use to crush the ore that stains the river red. It is also a work that combines views of the river with interiors of houses and photographs of the villages the river flows through. I have also used this strategy of photographing both the river and the inhabited areas near it.
AD: Exploring a bookshelf is the best first step of any journey. On mine, I found some passages that remind me of your way of taking photographs in a book by Robert Adams entitled Along Some Rivers: Photographs and Conversations. In particular, in the transcript of his opening speech at a debate held at the Fraenkel Gallery in San Francisco, Adams mentions the two qualities he always looks for in people and in the art they create, collect or admire: a sense of urgency and faithful accuracy. Faithfulness (often in contrast to originality) seems to me a possible key to your work.
LN: Along Some Rivers is a book of some of Adams’s conversations with various curators and includes a largely unpublished sequence of 28 photographs along the Rio Grande and Columbia River, following human traces in the landscape. When Robert Adams talks about faithfulness, or the search for some form of truth, he’s not talking about merely descriptive, or topographical, accuracy of the real world. The goal, he says, “is to face facts but to find a basis for hope. To try for alchemy”. It’s another way of rephrasing one of his most famous and much-quoted statements: “Landscape pictures can offer us, I think, three verities — geography, autobiography and metaphor. Geography is, if taken alone, sometimes boring; autobiography is frequently trivial; and metaphor can be dubious. But taken together… the three kinds of information strengthen each other and reinforce what we all work to keep intact — an affection for life.” This “alchemy” is of course sometimes achieved and sometimes not, but it is certainly a very inspiring approach. What I appreciate about Adams’s essays and interviews is that they are unencumbered by postmodern attitudes and theorizing, and each time I pick them up they make me want to take photographs. I realize now, flipping through Along Some Rivers, that Adams’s photographs are all vertical and in hindsight, perhaps, I should have done the same.
AD: The vertical format of Adams’s photographs allows us to introduce a distinctive aspect of your book: the orientation of the pictures in the sequence is always vertical regardless of the orientation of their subjects.
LN: The Columbia River is the same river photographed by Carleton E. Watkins in Photographs of the Columbia River and Oregon, one of my reference works. The crystal clarity of the photographs is impressive. There is a very beautiful and now hard-to-find book of this work from which I took the idea of “turning the photographs” for the final sequence: the format of the book is in fact horizontal, as are almost all the photographs, but the final sequence ends with four vertical landscapes – the silhouette of a mountain on a lake and three waterfalls – that are laid out on the page. The visual transition from horizontal to vertical, playing on the horizon line, is very subtle and delicate, but also very powerful, offering the opportunity for a more abstract and formal interpretation of the photographs. This idea inspired me to construct the sequence, considering the necessarily vertical format of the book. One of the things that struck me, arriving at the site of the sole well still open, was its size, in terms of both diameter and depth. The sensation of dizziness was very strong. Additionally, due to the depth and the black concrete blocks, on a normal sunny day the contrast of light between the illuminated part, and deep part in shadow, is too high and the film is unable to record both extremes. This is the reason why the line of the well, which in some photographs I have kept very high up in the shot, becomes a kind of horizon of photographic events, below which there is a kind of total darkness, an abyss. The idea of “rotating” the image on the page by placing it vertically was also to elicit or reinforce the sensation of dizziness.
AD: Let’s resume our back and forth of books.
LN: Another book that I think is very important, although little known, is The Subdury River: A Celebration by Frank Gohlke, published in 1993. It resonates with me because Gohlke uses the 13×18 colour format, which I also use a lot. The work has a biographical basis, for the photographer takes an interest in the river near his new home after moving to Massachusetts, setting in motion that process of discovery and creation through which we come to feel at home in our own particular parts of the world. In some ways I too, as a visiting outsider, used the Riachuelo to get to know Buenos Aires, instead of starting with the city’s “highlights” as a normal tourist would. And despite being “foreign” to the city, I sought an intimate viewpoint with certain areas of the river that I’d insisted on, rather than pursuing the visuals and modus operandi of the epic exotic journey. That’s why another reference I had in mind was Fiume (River) by Guido Guidi.
AD: Fiume is a compilation of a series of shots of the river that flows a few hundred metres from Guidi’s home in Cesena. The relationship with the everyday landscape, with that area that begins immediately beyond his doorstep, reminds us of the Senio and Santerno rivers that flooded the town and countryside of Lugo, one of the municipalities most affected by the floods in Emilia Romagna, where you grew up and where your family also lives.
LN: The flooding in Emilia-Romagna last May was as shocking as it was unexpected. I was at my grandparents’ house the morning it happened, and I’ll never forget the sight of the water slowly crossing the threshold. And the water as far as the eye could see across the open, flat landscape. The reasons for the floods are complex and manifold; certainly there were a number of concurrent unfortunate circumstances, and some have spoken of a “perfect storm”, but one of the main issues is undoubtedly the management of the rivers, riverbanks and land. This brings us directly back to the work on the Ghella construction site to relieve the Riachuelo river, which is at constant risk of flooding in certain neighbourhoods: as you said at the beginning, it’s a project that is as useful as it is invisible. I’m reminded of a comment by the painter and writer Christopher Neve in a book entitled Unquiet Landscapes (recently recommended to me by my friend John Spinks) about the painter John Nash, whose method of working could be compared to that of a water-diviner who “does not actually alter anything but who has some odd quality, that enables him to hint at what may be hidden, just by looking for places and objects which carried for him a particular charge”. After all, even good photography is a kind of perfect storm.
Una conversazione tra Luca Nostri e Alessandro Dandini de Sylva
AD: A differenza dei cantieri visitati dagli altri autori coinvolti in questa raccolta, il cantiere del bacino Matanza-Riachuelo, uno dei progetti di depurazione di acque reflue più complessi al mondo, al tuo arrivo a Buenos Aires era ormai quasi concluso. La nuova rete di tunnel era stata completata e i pozzi principali stavano per essere sigillati. Percorrere le sponde del Rio Matanza-Riachuelo fino alla sua foce nel Rio de la Plata, tra il barrio di La Boca e la città di Dock Sud, era l’unico modo per “vedere” un’infrastruttura invisibile che nei prossimi anni migliorerà la qualità di vita di oltre 14 milioni di persone.
LN: Quando mi è stato affidato il cantiere di Buenos Aires sono subito rimasto colpito dall’immaginario del fiume Riachuelo, che attraversa la città e sbocca sul Rio de La Plata, di fronte all’Uruguay, e che purtroppo è noto per lo più per problemi legati all’inquinamento, con gravi conseguenze sugli abitanti di alcuni quartieri critici della città. Mi è sempre interessata l’esplorazione geografica e topografica di un territorio, che mette dei confini al lavoro ma anche aiuta a pilotarlo, ed è di solito un’ottima scusa per uscire a fotografare. Con queste premesse, sono partito riguardando alcuni libri, tra cui The Red River di Jem Southam, che è stato mio tutor a Plymouth per il PhD. The Red River è ambientato in un territorio rurale, ma i punti di contatto sono molti: una sequenza di cinquanta fotografie che segue un corso d’acqua nell’ovest della Cornovaglia, dalla sorgente al mare, e che attraversa aree di diversa natura. L’intera valle del fiume è stata ampiamente sfruttata per centinaia di anni al fine di estrarne stagno e rame, e sono stati appunto l’estrazione dell’acqua dalla miniera e il suo utilizzo per frantumare il minerale a macchiare il fiume di rosso. Inoltre è un lavoro che mette insieme vedute del fiume, interni delle case e fotografie dei paesi attraversati dal fiume. Ho utilizzato anche’io la strategia di fotografare sia il fiume che le zone abitate nei suoi pressi.
AD: L’esplorazione di una libreria è il miglior primo passo di ogni viaggio. Nella mia, in un libro di Robert Adams dal titolo Along Some Rivers. Photographs and Conversations, ho ritrovato alcuni passaggi che mi parlano del tuo modo di fotografare. In particolare, nella trascrizione del suo discorso di apertura di un dibattito tenutosi alla Fraenkel Gallery di San Francisco, Adams indica le due qualità che cerca sempre nelle persone e nell’arte che esse creano, collezionano o ammirano: una sensazione di urgenza e una fedele esattezza. La fedeltà (spesso in contrapposizione all’originalità) mi sembra una possibile chiave di lettura del tuo lavoro.
LN: Along Some Rivers è un libro che raccoglie alcune delle conversazioni di Adams con diversi curatori, e include una sequenza per lo più inedita di 28 fotografie scattate lungo il Rio Grande e il Columbia River, seguendo le tracce dell’uomo nel paesaggio. Quando Robert Adams parla di fedeltà, o della ricerca di una qualche forma di verità, non parla di una mera esattezza descrittiva, o topografica, del mondo reale. L’obiettivo, dice, “è affrontare i fatti, ma per trovare una base per la speranza. Tentare l’alchimia”. È un altro modo di riformulare una delle sue più famose e citate affermazioni: “Le immagini di paesaggio possono presentarci tre verità: la verità geografica, quella autobiografica e quella metaforica. La geografia di per se stessa è a volte noiosa, l’autobiografia spesso banale, e la metafora può essere equivoca. Ma presi insieme… questi tre tipi di informazione si rafforzano a vicenda e alimentano ciò che tutti cerchiamo di mantenere intatto: l’attaccamento alla vita”. Questa “alchimia” naturalmente a volte si crea e a volte no, ma di certo è un approccio di grande ispirazione. Ciò che apprezzo dei saggi e delle interviste di Adams è che sono liberi da atteggiamenti e teorizzazioni postmoderne, e ogni volta che li riprendo in mano mi fanno venire voglia di fotografare. Realizzo ora, sfogliando Along Some Rivers, che le fotografie di Adams sono tutte verticali e col senno di poi, forse, avrei dovuto fare lo stesso.
AD: La verticalità delle fotografie di Adams ci permette di introdurre un aspetto peculiare del tuo libro: l’orientamento delle immagini nella sequenza è sempre verticale a prescindere dall’orientamento dei loro soggetti.
LN: Il Columbia River è lo stesso fiume fotografato da Carleton E. Watkins in Photographs of the Columbia River and Oregon, una delle mie opere di riferimento. La chiarezza cristallina delle fotografie è impressionante. Di questo lavoro esiste un libro molto bello e ormai difficile da trovare da cui ho preso l’idea di “girare le fotografie” per la sequenza finale: il libro infatti è di formato orizzontale, come quasi tutte le fotografie, ma la sequenza finale si chiude con quattro paesaggi verticali, il profilo di una montagna su un lago e tre cascate. Il passaggio visivo dall’orizzontalità alla verticalità, giocando sulla linea dell’orizzonte, è molto sottile e delicato, ma anche molto potente, e consente di interpretare le fotografie in modo più astratto e formale. Mi sono ispirato a questa idea per costruire la sequenza, considerando il formato necessariamente verticale del libro. Una delle cose che mi ha colpito, arrivando sul cantiere dell’unico pozzo ancora aperto, è stata la sua dimensione, sia per diametro che per profondità. La sensazione di vertigine era molto forte. Inoltre, a causa della profondità e dei blocchi di cemento di colore nero, in una normale giornata di sole il contrasto di luce tra la parte illuminata, e quella in ombra in profondità, è troppo elevato e la pellicola non riesce a registrarne entrambi gli estremi. Per questo motivo la linea del pozzo, che in alcune fotografie ho tenuto molto in alto nell’inquadratura, diventa una sorte di orizzonte degli eventi fotografici, al di sotto del quale si finisce in una sorta di buio totale, di abisso. L’idea di “ruotare” l’immagine sulla pagina, mettendola in verticale, era anche quella di suscitare o rinforzare la sensazione di vertigine.
AD: Continuiamo il nostro ping pong bibliografico.
LN: Un altro libro che ritengo molto importante, anche se poco conosciuto, è The Subdury River. A celebration di Frank Gohlke, pubblicato nel 1993. Questo lavoro mi coinvolge perché Gohlke utilizza il formato 13×18 a colori, che uso molto anch’io. Il lavoro ha delle premesse biografiche: il fotografo si interessa al fiume vicino alla sua nuova casa, dopo essersi trasferito nel Massachusetts, e attiva quel processo di scoperta e creazione attraverso il quale arriviamo a sentirci a casa nelle nostre specifiche parti del mondo. In qualche modo anche io, da visitatore esterno, ho utilizzato il Riachuelo per prendere confidenza con Buenos Aires, invece di partire dagli “highlights” della città come farebbe un normale turista. E nonostante il mio essere “alieno” alla città, ho cercato un punto di vista intimo con alcune zone del fiume sulle quali ho insistito, invece di cercare l’estetica e il modus operandi del viaggio epico ed esotico. Ecco perché un altro riferimento che avevo in mente era Fiume di Guido Guidi.
AD: Fiume raccoglie una serie di fotografie del fiume che scorre a poche centinaia di metri dall’abitazione di Guidi a Cesena. Il rapporto con il paesaggio quotidiano, con quel territorio che inizia immediatamente oltre la soglia di casa, ci rimanda ai fiumi Senio e Santerno, i corsi d’acqua che a causa del maltempo sono straripati allagando il centro e le campagne di Lugo, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione dell’Emilia Romagna, dove sei cresciuto e dove vive anche la tua famiglia.
LN: L’alluvione dello scorso maggio in Emilia-Romagna è stata una esperienza scioccante quanto inaspettata. Ero a casa dei miei nonni la mattina in cui è arrivata, e l’immagine dell’acqua che lentamente varca la soglia di casa non la dimenticherò mai. Così come quella dell’acqua a perdita d’occhio nel paesaggio aperto e pianeggiante. Le ragioni di quello che è successo sono complesse e molteplici; di sicuro ci sono state una serie di circostanze sfortunate concomitanti, e qualcuno ha parlato di “tempesta perfetta”, ma uno dei temi principali è senza dubbio la gestione dei fiumi, degli argini e del territorio. Questo ci riporta direttamente all’intervento del cantiere Ghella di alleggerimento del fiume Riachuelo, che in alcuni quartieri è costantemente a rischio esondazione: come dici all’inizio del testo, è un intervento tanto utile quanto invisibile. Mi viene in mente un commento del pittore e scrittore Christopher Neve in un libro dal titolo Unquiet Landscapes (consigliatomi di recente dal mio amico John Spinks) a proposito del pittore John Nash, il cui metodo di lavoro potrebbe essere paragonato a quello di un rabdomante che “in realtà non altera nulla, ma che ha una qualche strana capacità che gli consente di cogliere ciò che potrebbe essere nascosto, semplicemente cercando luoghi e oggetti che avevano veicolato per lui una particolare ‘carica”. In fondo, anche una buona fotografia è una sorta di tempesta perfetta.
Giulia Parlato and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
The world is blue at its edges and in its depths. This blue is the light that got lost.1
AD: Examining the hundreds of pictures from the company’s construction sites, mostly photographs documenting the states of progress and key moments in the life of the sites, allowed us to pick out imagery relevant to the work of the artists involved. Each of the photographers was associated with a particular site, considering the possible directions that various artistic approaches could take in each of the scenarios. The intention was in fact to use the construction sites as a source of inspiration for an unprecedented series of visual adventures. However, in your case, things turned out differently.
GP: Yes, that’s true. When you told me that Auckland was one of the possible destinations, it seemed like an unmissable opportunity for me to finally visit a place that’s always been part of my family history. A place that over the years has assumed fantastical traits, due to both the stories and its geographical remoteness. I grew up listening to my great-grandmother Giulia’s stories, one of which was about her son Francesco, who disappeared in New Zealand in the 1964. Francesco had travelled a lot, moving many times in search of himself. He spoke several languages, painted and wrote poetry, and had an inquisitive but melancholy nature. After having worked for a few years at a local newspaper called The Auckland Star, he decided to move to Taupaki, a town a few kilometres north-west of Auckland. He grew roses in his garden and planned to build a greenhouse. Then one day he vanished. At home we kept the letters, poems, dried flowers, paintings, photographs and postcards he’d sent to his family in Sicily.
AD: The imagery of 1960s New Zealand and the memories of your far-off great-uncle created a particular atmosphere, a platform on which you built your own idea of the project in terms of the technical specifications of the site, the implications for the natural landscape and relations with the Māori communities.
GP: New Zealand immediately strikes you with its spectacular, unspoiled natural landscapes in which to lose yourself. Taking the aesthetic aspect of the visual material left by Francesco as my starting point, I chose to explore the landscape and geological features that distinguish the excavation work, using colour photography and a view camera. Moving away from my usual method of working, I limited my research to the bare essentials before starting to take photographs. Once I’d identified the main elements that I knew would be my starting point, I chose to be guided by the people I’d meet, the things that would intrigue me along the way and the stories I’d discover. The focus on preserving the area’s biodiversity and the numerous projects to restore the landscape that will follow these excavation works are impressive. I’m not just talking about the effects strictly related to the construction of the tunnel, but also to those regarding the volcanic island of Puketutu, where the earth extracted from the underground construction site is transported. Before it was exploited and irremediably transformed to build Auckland airport, Puketutu was a sacred place for the Māori. The new construction site has allowed the island’s original appearance to be restored. In short, the highly organized, technological, artificial excavation sites scattered throughout the city are in perfect harmony with the surrounding natural landscape, forming part of a construction and reconstruction project that is, in my opinion, cultural more than anything else. The historical authenticity of a place is the key through which my photographic work takes shape. I’m interested in the fragments of a distant, forgotten past. Partial clues and all that is hidden or missing are often the subjects of my pictures.
AD: Your first-hand experience of the site yielded a series of impressions that helped shape your visual approach. In our exchanges you repeatedly used Captain Nemo’s Nautilus as an evocative analogy of being inside the tunnel and the TBM. Searching online, I discovered that, in addition to being the name of the submarine that appears in Jules Verne’s novels Twenty Thousand Leagues Under the Sea and The Mysterious Island, Nautilus was also the name of the first underwater boat built in 1800 and the first nuclear-powered submarine built in 1954. The word nautilus comes from the name of an extraordinary marine creature, an ancient mollusc that inhabits a spiral shell and has a primitive visual system: its eye functions like a pinhole camera, whereby focus works at the expense of brightness and vice versa; all aspects that I later found in your pictures.
GP: Before I got there, I hadn’t really grasped the site’s extraordinary dimensions. In order to reach the main TBM, I had to descend by lift via one of the shafts from which the freshly extracted spoil was constantly transported. The tunnel commenced at the bottom. There was a little train but I decided to walk so that I could stop and take photographs. I walked about two kilometres before I saw the excavation face. At first in silence and then accompanied by mechanical noises, voices and laughter. For anyone unaccustomed to such scenarios, finding yourself in the construction site of a tunnel under the sea conjures up sci-fi fantasies. When you arrive at the TBM, you really feel as though you’re in a submarine. There are several floors, a computer room, all sorts of scaffolding, cables and devices. The many people who work there, move almost in unison, at ease, passing each other materials, tools or a coffee. The term nautilus effectively sums up the atmosphere of this work. It refers not only to the concept of adventure and discovery but also to the tunnel and the submarine, the bird’s-eye views and the forests, the mysteries of the Earth and palaeontology. After all, the still-lifes with fossils that I photographed at the Auckland War Memorial Museum are the real protagonists of this story.
AD: In the book, pictures of the shells and marine fossils found at the construction site are alternated with glimpses of the tunnel and the site itself, views of Auckland, the coastline and the unspoiled natural landscape, particularly the island of Puketutu.
GP: The sequence we’ve chosen for the book is a round trip across the landscape of Auckland and the construction site, from the sky to below ground. The choice to contrast the features of the construction site with the surrounding natural scenery was prompted by observing the similarity between the spoil extracted from the tunnel and transported to Puketutu for the reconstruction of the original scoria cones and the area’s rocks and volcanic sand beaches. The few human figures appear distant and lost in sweeping landscapes, while the fossils are described up close, viewed like prehistoric creatures swimming in the sea. And so, as in my previous works, materials are key. Materials that change texture, shape, geographical location, historical meaning and cultural significance before our eyes.
AD: The relationship with your artistic research and practice, materials, memory, invisibility and rediscovery: everything seems to bring us back to your personal story. A series of coincidences – some unexpected, others sought – probably aligned to show you the way towards a new work.
GP: My fascination with history and rediscovering the past, with what is distant, submerged or invisible, certainly has something to do with the time I spent listening to my great-grandmother Giulia. She was a great storyteller. She’d tell me about her childhood and the games she played with her many cousins, about her absent and distant father, about when the Germans burned her house down during the Second World War and her long journey across Italy with her children. Ever since I was a child, all of these things have led me to wonder about the imaginative power of storytelling, the way we tell the past and how it is told to us by others. Francesco and I never met, yet I was thrilled to take his map of Auckland – on which he’d made notes to show his parents where he lived and the places he frequented – back to the city. His story deals with issues very close to me, which I intend to explore further. I’ve just started to work on a new project that focuses on the act of vanishing and on landscape as testimony, and which was spawned by the musings and notes that I took during my trip to New Zealand. I’m happy that I’ll soon start photographing again.
1 Rebecca Solnit (2017), A Field Guide to Getting Lost, Edinburgh, Canongate Books.
Una conversazione tra Giulia Parlato e Alessandro Dandini de Sylva
Il mondo è blu ai suoi margini e nelle sue profondità. Questo blu è la luce che si è persa.1
AD: Lo studio delle centinaia di immagini provenienti dai cantieri dell’azienda, perlopiù fotografie che documentano i progressivi stati di avanzamento e i momenti decisivi nella vita dei cantieri, ci ha permesso di scorgere immaginari rilevanti per le ricerche degli artisti coinvolti. Ciascuno degli autori è stato associato ad un particolare cantiere, valutando le possibili derive che differenti pratiche artistiche avrebbero potuto prendere in ognuno dei contesti. L’intento era proprio quello di usare i cantieri come fonte di ispirazione per una inedita serie di avventure visive. Con te, però, le cose sono andate in modo diverso.
GP: Sì, è vero. Quando mi hai detto che Auckland era una delle possibili destinazioni, mi è sembrata un’occasione imperdibile per visitare finalmente un luogo che ha sempre fatto parte della mia storia familiare. Un luogo che nel tempo, sia per i racconti sia per la lontananza geografica, ha assunto tratti fantasmatici. Sono cresciuta ascoltando le storie della mia bisnonna Giulia. Una di queste è la storia di suo figlio Francesco, scomparso in Nuova Zelanda nel 1964. Francesco aveva viaggiato molto, spostandosi spesso, alla ricerca di sé stesso. Parlava diverse lingue, dipingeva, scriveva poesie. Era un curioso ma anche una persona malinconica. Dopo aver lavorato per qualche anno per il giornale locale “Auckland Star”, decise di trasferirsi a Taupaki, una località pochi chilometri a nord-ovest di Auckland. Coltivava rose nel giardino di casa e progettava di costruire una serra. Poi un giorno scomparve. In casa abbiamo conservato fotografie, cartoline, lettere, poesie, fiori essiccati e dipinti che Francesco spediva ai suoi familiari in Sicilia.
AD: L’immaginario della Nuova Zelanda degli anni Sessanta e i ricordi del tuo lontano prozio hanno determinato una particolare atmosfera, un plateau su cui hai costruito una tua idea del lavoro in relazione alle caratteristiche tecniche del cantiere, alle implicazioni per il paesaggio naturale e al rapporto con le comunità Māori.
GP: La Nuova Zelanda colpisce subito per gli spettacolari ed incontaminati paesaggi naturali in cui perdersi. Partendo dall’estetica del materiale visivo lasciato da Francesco, ho scelto di esplorare gli aspetti paesaggistici e geologici che contraddistinguono questa campagna di scavi, utilizzando la fotografia a colori e il banco ottico. Allontanandomi dal mio usuale metodo di lavoro, ho limitato all’essenziale la ricerca prima di iniziare a fotografare. Una volta individuati gli elementi principali che sapevo avrebbero costituito il mio punto di partenza, ho scelto di farmi guidare dalle persone che avrei incontrato, da ciò che mi avrebbe affascinato lungo la strada, dalla storie che avrei scoperto. L’attenzione alla biodiversità del territorio e le numerose iniziative di restituzione del paesaggio che questi lavori di scavo comportano sono impressionanti. Non parlo solo degli effetti prettamente legati alla costruzione del tunnel ma anche di quelli riguardanti l’isola vulcanica di Puketutu, dove viene trasportata la terra estratta dal cantiere sotterraneo. Prima che venisse sfruttata e irrimediabilmente trasformata per la costruzione dell’aeroporto di Auckland, Puketutu era un luogo sacro per i Māori. Grazie al nuovo cantiere si sta riportando l’isola alle sue sembianze originarie. In sostanza, i siti di scavo diffusi nella città, super organizzati, tecnologici e artificiali, sono in perfetta sintonia con la natura circostante, in un progetto di costruzione e ricostruzione, dal mio punto di vista più di ogni altra cosa, culturale. L’autenticità storica di un luogo è la chiave attraverso la quale prende forma la mia ricerca fotografica. Mi interessano i frammenti appartenenti a un passato lontano, dimenticato. Gli indizi parziali e tutto ciò che è nascosto o mancante sono spesso i protagonisti delle mie immagini.
AD: L’esperienza diretta del cantiere ha generato una serie di impressioni che hanno contribuito a formare il tuo approccio visivo. Nei nostri scambi hai più volte usato il Nautilus del capitano Nemo come riferimento atmosferico del trovarsi all’interno del tunnel e della TBM. Cercando su Internet, ho scoperto che Nautilus, oltre ad essere il nome del sommergibile che compare nei romanzi Ventimila leghe sotto i mari e L’isola misteriosa di J. Verne, è anche il nome del primo battello sommergibile costruito nel 1800 e del primo sottomarino a propulsione atomica costruito nel 1954. La parola nautilus viene dal nome di uno straordinario animale marino, un mollusco antichissimo che vive nella sua conchiglia a spirale ed è dotato di un sistema visivo primitivo: il suo occhio funziona come una camera oscura, in cui la messa a fuoco penalizza la luminosità e viceversa. Tutte suggestioni che ho poi ritrovato nelle tue immagini.
GP: Prima di arrivare, non avevo chiara la straordinaria dimensione del cantiere. Per raggiungere la TBM principale sono dovuta scendere con un ascensore in uno dei pozzi da cui veniva continuamente trasportata la terra appena estratta. In fondo, iniziava il tunnel. C’era un trenino ma ho deciso di muovermi a piedi per potermi fermare e fotografare. Ho camminato per circa due chilometri prima di vedere il fronte di scavo. All’inizio nel silenzio, poi tra rumori meccanici, voci e risate. Per chiunque non sia abituato a scenari di questo tipo, ritrovarsi nel cantiere di un tunnel sotto il mare evoca immaginari fantascientifici. Arrivati alla TBM, si ha davvero la sensazione di essere dentro un sottomarino. Ci sono diversi piani, una sala computer, impalcature, cavi e marchingegni di ogni sorta. Le numerose persone che ci lavorano, si muovono quasi in sincronia, a proprio agio, passandosi materiali, strumenti o un caffè. La parola nautilus racchiude bene l’atmosfera di questo lavoro. Fa riferimento non solo all’idea di avventura e scoperta ma anche al tunnel e al sottomarino, alle vedute dall’alto e alle foreste, ai misteri della Terra e alla paleontologia. In fondo, le nature morte con i fossili che ho fotografo all’Auckland War Memorial Museum sono i veri protagonisti di questa storia.
AD: Nel libro, le immagini delle conchiglie e dei fossili marini ritrovati nel cantiere si alternano a scorci del tunnel e del cantiere, a vedute di Auckland, della costa e della natura incontaminata e, in particolare, dell’isola di Puketutu.
GP: La sequenza che abbiamo scelto per il libro è un viaggio di andata e ritorno attraverso il paesaggio di Auckland e del cantiere, dal cielo al sottosuolo. La scelta di contrapporre gli elementi del cantiere agli scenari naturali circostanti è venuta notando la somiglianza tra la terra estratta dal tunnel e trasportata a Puketutu per la ricostruzione dei coni vulcanici originari e le rocce e le spiagge di sabbia lavica di quell’area. Le poche figure umane appaiono lontanissime e immerse in paesaggi sconfinati, mentre i fossili sono raccontati da molto vicino, osservati come creature preistoriche che nuotano nel mare. Come nei miei lavori passati, la materia è quindi al centro. Una materia che cambia consistenza, forma, posizione geografica, senso storico e significato culturale davanti ai nostri occhi.
AD: Il rapporto con la tua ricerca e pratica artistica, la materia, la memoria, l’invisibilità e la riscoperta, tutto sembra riportarci alla tua vicenda personale. Probabilmente una serie di coincidenze, alcune inaspettate, altre cercate, si sono allineate per indicarti la strada verso un nuovo lavoro.
GP: La mia fascinazione per la storia e per la riscoperta del passato, per ciò che è distante, sommerso o invisibile, ha sicuramente a che fare con il tempo passato ad ascoltare la mia bisnonna Giulia. Era una grande narratrice. Mi raccontava della sua infanzia e dei giochi che faceva con i suoi numerosi cugini, del padre assente e lontano, di quando i tedeschi le hanno bruciato la casa durante la Seconda Guerra Mondiale e del lungo peregrinare attraverso l’Italia con i suoi figli. Tutto questo mi ha portata sin da bambina a pormi domande sul potere immaginifico della narrazione, sul modo in cui raccontiamo il passato e su come ci viene raccontato da altri. Io e Francesco non ci siamo mai conosciuti, eppure l’aver riportato ad Auckland la sua mappa della città, sulla quale aveva preso appunti per mostrare ai suoi genitori dove abitava e i posti che frequentava, mi ha emozionata. La sua storia affronta temi a me molto vicini, che ho intenzione di approfondire. Ho appena iniziato a sviluppare un nuovo progetto che parla dell’atto di scomparire e del paesaggio come testimonianza, e che è nato in seguito a riflessioni e appunti che ho preso durante il viaggio in Nuova Zelanda. Sono felice di ricominciare presto a fotografare.
1 Rebecca Solnit, A Field Guide To Getting Lost, Canongate Books, Edinburgh 2017.
Rachele Maistrello and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
Who needs to travel thousands of miles to find the new? The most mysterious place on Earth is right beneath our feet.1
AD: In 1768, James Cook set sail on the Endeavour tasked with exploring the Pacific Ocean, observing the 1769 transit of Venus across the Sun and searching for evidence of the existence of the Terra Australis. The expedition crossed the Atlantic, rounded Cape Horn, arrived in Tahiti in time for the transit of Venus and continued on to New Zealand, before reaching the east coast of Australia in 1770. Cook was the first European to explore the coastline of the new continent and map it by drawing nautical charts and coastal views. A group of naturalists and artists led by Joseph Banks accompanied this valuable mapping with an equally precious collection and classification of numerous species of exotic plants and animals completely unknown to European science. A double mapping that I unexpectedly encountered in your work and discovered that deeply belongs to your view of the world.
RM: This approach has deep roots. Even in my childhood, the mapping of space followed double coordinates: classic space-time ones and other secret, labyrinthine ones that belonged to the world of my father, a keen ornithologist. For him, the seasons were marked by the late or early appearance of migratory species, geography was deduced not from the four cardinal points but from invisible trajectories of bird songs among the vegetation. Moving a few metres from home was enough to glean infinite possible worlds: a piece of bamboo was transformed into a three-note whistle, a branch of a common boxwood hedge into a very precise bow. Australia was his El Dorado: a reservoir of unique bird species, a place of unspoiled vegetation; it was the fuel of his most vivid dreams and the subject of the volumes that filled our bookcase. As time goes by, I’m noticing his coordinates in my own eye, like an inner puzzle, and discovering the great truth of his words: la vida es sueño.
AD: Your photographic campaign is probably the most mysterious of those realized so far. Entrusting you with the Brisbane site opened up storytelling possibilities and visual drifts that we hadn’t expected.
RM: When you contacted me to ask if I wanted to go to Australia, for me it was a synchronic event, an urge to probe a mythological narrative about my own origins. In a way, I felt like Estrella setting off for the South. But why, I wondered, did this synchronicity want me in Australia, yet not in my father’s beloved places of light, song and colour, but metres and metres below the surface, in the mud and darkness of an excavation for a gigantic infrastructure? Perhaps because, like Estrella, I was also hoping to find the origins of a family secret, which for her, it just so happens, was dowsing, or the art of finding water in the underground depths?
AD: Estrella’s South has to do with an inner geography whose coordinates are memory and dreams. A territory that you’ve decided to explore by following anti-narrative paths and tracing maps that, like the “songlines” described by Bruce Chatwin, superimpose identity, culture and landscape.
RM: I knew that the work I would bring home would follow an inner logic, my own personal songline, and that I would have to have faith in what might at first seem even outlandish or illogical. My inner guide while exploring the site and the city was in fact Bruce Chatwin, the man who, upon his return from Australia, would recount the famous songlines, or maps of the land that the Aborigines handed down orally, constructing a territorial and ancestral geography of their ancestors. What songline would reveal itself to me in the Ghella excavations, up and down between the sunny world and the damp darkness of the caves?
AD: Looking at your work, you get the feeling that you’ve done the opposite of the other artists involved in the project. Instead of projecting the landscape of the construction site onto your imagination, you poured your imagination into the construction site, populating the excavations with magical creatures, mysterious figures and nocturnal animals.
RM: The first site I visited was Albert Site. It’s the one that I felt, more than any other excavation, was immediately the focus of everything. A few weeks before my arrival, a huge coiled carpet python (Morelia spilota) had been found right at the entrance to the construction site and had been released into the wild, as required by Australian law, in the nearest park, the City Botanic Gardens, a short walk from my hotel. Here were the first coordinates of the map I was looking for. My eye thus immediately turned to Albert Site by day and the botanical garden by night, transforming everyday life into an eclipse of darkness and humidity. At dusk, from the construction site, a strangely protective hypnotic and magnetic place, I would run to the botanical garden to see the nocturnal animals appearance. First the giant bats that seemed to come from the realm of the excavation, then, in the dark, the possums, shy animals that once led me to the centre of the park towards an unexpected meeting: a girl, an alter ego of mine from ten or fifteen years ago. She was alone facing her fears, risking a little, just like me.
AD: Alongside your observation of the construction site, you also gathered information that allowed you to complete an important ethnographic survey involving workers, engineers and technicians in the space of a few days. How did you manage to intercept their suggestions and to what extent did the imagery that emerged change or amplify your view?
RM: I distributed anonymous questionnaires to employees: was the excavation a positive or negative presence? Had they ever dreamed about it? Had they ever missed it after leaving it? Many of them experienced it as a particularly feminine force, like a whale’s belly or a predatory but never evil animal. Some of them missed the site, even at weekends. All of them had dreamt about it. The idea of collective work, of building a space, albeit by subtraction, emerged from all the questionnaires. Perhaps the archetype of the feminine, Courbet’s Origine du Monde, is hidden within its painted caves and the bellies of these rock whales enclose a force more feminine than masculine, reminiscent of the Palaeolithic and Neolithic Great Mother myths. Perhaps it is this figure that I sought, or that called me back, among the animals and the crevices of the rocks, like a mirror reflecting my inner self. A figure that runs through mythology and originates in the European pre-Indo-Neolithic matriarchal societies, the Great Mother is connected not only with terrestrial forces, but also with the moon, water, the unconscious, and all forms that can be assimilated with the womb, such as the cave.4
AD: The tunnel for Brisbane’s new underground railway line was transformed into a cavern of the unconscious before your eyes, a nocturnal theatre in which to stage the dreamlike imagery of the excavation and give form to intangible aspects of the construction site that tell us about its landscape, its inhabitants and, perhaps, even a little about you.
RM: In this new geography, in which space is dictated by connections of sense and not space, without a well-defined layout, in a sort of liberating expedition, I also discovered the pure joy of the image, the portrait. This took me back to other origins: to my very first works, when I was training with my first two teachers, Guido Guidi, who taught me to go slowly, to walk, to wait calmly for the image, and Agamben, who taught me to fearlessly assemble, stitch and revise the apparent linearity of the present.
1 William Bryant Logan (1995), Dirt: The Ecstatic Skin of the Earth, New York, Riverhead Books.
2 In the film El Sur (1983) by Víctor Erice, Estrella, in the cold north of Spain, dreams of the South of her father, a charismatic mysterious man. For her, the South is a place whispered about and hushed within the walls of her home, spied among postcards hidden in the cellar; it is the place that holds the secret of her dad’s dowsing skills, which she herself witnessed in her earliest childhood.
3 Bruce Chatwin (1987), The Songlines, London, Picador.
4 Mircea Eliade (1980) La prova del labirinto, Milan, Jaca Book.
Una conversazione tra Rachele Maistrello e Alessandro Dandini de Sylva
A cosa serve viaggiare centinaia di chilometri per scovare mondi nuovi? Il luogo più misterioso di tutta la Terra si trova proprio sotto di noi.1
AD: Nel 1768, James Cook salpò sulla nave Endeavour con l’incarico di esplorare l’Oceano Pacifico, osservare il transito di Venere davanti al Sole e cercare le prove dell’esistenza della Terra Australis. La spedizione attraversò l’Atlantico, doppiò Capo Horn, giunse a Tahiti in tempo per il transito di Venere e proseguì verso la Nuova Zelanda per poi raggiungere la costa orientale dell’Australia nel 1770. Cook fu il primo europeo a esplorare la linea di costa del nuovo continente e a tracciarne la mappa disegnando carte nautiche e vedute costiere. A questa preziosa mappatura, un gruppo di naturalisti e artisti guidati da Joseph Banks affiancò un’altrettanto preziosa raccolta e catalogazione di molte specie di piante e animali esotici del tutto sconosciuti alla scienza europea. Una doppia mappatura che ho ritrovato in modo inaspettato nel tuo lavoro e che ho scoperto appartenere profondamente al tuo sguardo sul mondo.
RM: Questa attitudine ha radici profonde. Già nella mia infanzia, la mappatura dello spazio seguiva doppie coordinate: quelle spazio-temporali classiche ed altre, labirintiche e segrete, che appartenevano al mondo di mio padre, appassionato ornitologo. Le stagioni per lui erano scandite dal ritardo o dall’anticipo delle specie migratorie, e la geografia non era dedotta dai quattro punti cardinali, bensì dalle traiettorie invisibili dei canti degli uccelli tra la vegetazione. Bastava allontanarsi pochi metri da casa per raccogliere infiniti mondi possibili: un pezzo di bambù si trasformava in un fischietto a tre note, il ramo di una comune siepe di bosso in un arco precisissimo. L’Australia era il suo Eldorado: riserva di specie ornitologiche uniche, luogo di vegetazione incontaminata, era la benzina dei suoi sogni più vividi ed il tema dei volumi che riempivano la nostra libreria. Con l’andare del tempo sto ritrovando le sue coordinate nel mio sguardo, come in un puzzle interiore, e scoprendo quanto sia vero ciò che mi ripeteva sempre: la vida es sueño.
AD: La tua campagna fotografica è probabilmente la più misteriosa tra quelle realizzate finora. Affidarti il cantiere di Brisbane ha aperto possibilità di racconto e derive visive che non avevamo previsto.
RM: Quando mi hai chiesto di andare in Australia, per me si è trattato di un evento sincronico, un impulso a sondare una narrazione mitologica sulle mie stesse origini. Mi sono sentita, in un certo senso, Estrella che parte per il Sud. Ma perché, mi sono chiesta, questa sincronicità mi voleva in Australia ma non nei luoghi amati da mio padre, fatti di luce, canti e colori, bensì a metri e metri sotto la superficie, tra il fango e il buio di uno scavo per una gigantesca infrastruttura? Forse perché anche io, come Estrella, speravo di trovare le origini di un segreto di famiglia, che per lei è, guarda caso, la rabdomanzia, ovvero l’arte di trovare l’acqua nelle profondità sotterranee?
AD: Il Sud di Estrella ha a che fare con una geografia interiore che ha come coordinate la memoria e il sogno. Un territorio che hai deciso di esplorare seguendo sentieri anti-narrativi e tracciando mappe che, come le “vie dei canti” descritte da Bruce Chatwin in The Songlines (1987), sovrappongono identità, cultura e paesaggio.
RM: Sapevo che il lavoro che avrei portato a casa avrebbe seguito una logica tutta interiore, la mia songline personale, e che avrei dovuto avere fede in ciò che nell’immediato sarebbe potuto sembrare anche stravagante o illogico. La mia guida interiore nell’esplorazione del cantiere e della città è stata proprio Bruce Chatwin, colui che ritornando dall’Australia narrerà delle famose songlines,3 ovvero delle mappe del territorio che gli aborigeni tramandano oralmente, costruendo una geografia territoriale e ancestrale. Quale songline mi si sarebbe rivelata tra gli scavi di Ghella, su e giù tra il mondo solare e l’umida oscurità delle grotte?
AD: Guardando il tuo lavoro si ha la sensazione che tu abbia compiuto un’operazione opposta rispetto agli altri autori coinvolti nel progetto. Invece di proiettare il paesaggio del cantiere nel tuo immaginario, hai riversato il tuo immaginario nel cantiere, popolando gli scavi di creature magiche, figure misteriose e animali notturni.
RM: Il primo sito che ho visitato è stato Albert Site, ed è quello che più di ogni altro scavo ho sentito, da subito, essere il fulcro di tutto. Qualche settimana prima del mio arrivo, proprio all’entrata del cantiere era stato rinvenuto un enorme serpente arrotolato, un esemplare di Morelia Spilota, che era stato rilasciato in libertà, come prevede la legge australiana, nel parco più vicino, ovvero presso il City Botanic Gardens, a pochi passi dal mio hotel. Ecco le prime coordinate della mappa che stavo cercando. Il mio sguardo si è rivolto dunque ad Albert Site di giorno e al giardino botanico di notte, trasformando la quotidianità in un’eclissi di buio e umidità. Al tramonto, dal cantiere, luogo ipnotico, magnetico e stranamente protettivo, correvo al giardino botanico per vedere apparire gli animali notturni. Prima i pipistrelli giganti, che sembravano provenire dal regno dello scavo, poi, con il buio, i possum, animali schivi che una volta mi hanno condotta al centro del parco verso un incontro inaspettato: una ragazza, un mio alter ego di dieci o quindici anni fa, affrontava le sue paure rischiando un po’, come stavo facendo io.
AD: All’osservazione del cantiere hai affiancato un processo di raccolta di informazioni che ti ha permesso di completare in pochi giorni una significativa ricerca etnografica coinvolgendo operai, ingegneri e tecnici di vario genere. Come sei riuscita a intercettare le loro suggestioni e in che misura l’immaginario emerso ha modificato o amplificato il tuo sguardo?
RM: Ho distribuito ai dipendenti questionari anonimi: lo scavo era una presenza positiva o negativa? Lo avevano mai sognato? Gli era accaduto che gli mancasse, una volta usciti? Molti lo vivevano come una forza soprattutto femminile, un ventre di balena, o come un animale predatorio ma mai malvagio. Ad alcuni il cantiere mancava, anche nel fine settimana. Tutti lo avevano sognato. In tutti i questionari emergeva l’idea del lavoro collettivo, della costruzione di uno spazio, seppur in sottrazione. L’archetipo del femminile, L’Origine du Monde di Courbet, forse è nascosto tra le sue grotte dipinte, ed il ventre di queste balene di roccia racchiude una forza più femminile che maschile, che ricorda i miti paleolitici e neolitici della Grande Madre. Forse è questa figura che ho cercato, o mi ha richiamata, tra gli animali e le fenditure delle rocce, come uno specchio verso la mia interiorità. Figura che attraversa la mitologia e nasce nelle società matriarcali pre-indo-neolitiche europee, la Grande Madre risulta collegata non solo con le forze telluriche, ma anche con la luna, l’acqua, l’inconscio, e con tutte le forme assimilabili al grembo materno, come la caverna.
AD: Il tunnel della nuova linea metropolitana sotterranea di Brisbane si è trasformato sotto i tuoi occhi in una caverna dell’inconscio, un teatro notturno in cui mettere in scena l’immaginario onirico dello scavo e dare forma ad aspetti intangibili del cantiere che ci parlano del suo paesaggio, dei suoi abitanti e, forse, anche un po’ di te.
RM: In questa nuova geografia, in cui lo spazio è dettato da legami di senso e non di spazio, priva di un progetto ben definito, in una sorta di spedizione liberatoria, ho ritrovato anche la pura gioia dell’immagine, del ritratto. Ciò mi ha riportata ad altre origini: ai miei primissimi lavori, quando mi formavo con i miei due primi maestri, Guido Guidi, che mi ha insegnato ad andare piano, a camminare, ad aspettare con calma l’immagine, e Agamben, che mi ha insegnato ad assemblare, cucire e revisionare senza paure l’apparente linearità del presente.
1 William Bryant Logan, La pelle del pianeta. Storia della terra che calpestiamo, Bollati Boringhieri, Torino 2011.
2 Nel film El Sur (1983) di Víctor Erice, Estrella, nel freddo nord della Spagna, sogna il Sud di suo padre, un uomo carismatico e misterioso. Il Sud per lei è un luogo sussurrato e taciuto tra le mura di casa, spiato tra cartoline nascoste in cantina, è il luogo che custodisce il segreto delle doti rabdomantiche del suo papà, delle quali lei stessa è stata testimone nella primissima infanzia.
3 Bruce Chatwin, Le vie dei canti [The Songlines], Adelphi, Milano 1987.
4 Mircea Eliade, La prova del labirinto, Jaca Book, Milano 1980.
Stefano Graziani and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: Your exploration of the clichés of photography, the motifs that identify a photograph as belonging to a particular category, and the limits of these definitions could be a possible key to understanding your work on the Millennium Line Extension construction site in Vancouver. The pictures you’ve taken along the Broadway Corridor, one of Canada’s busiest transit routes, seem to challenge the genre of industrial photography by straying into that of street photography. Both the views of the underground construction site and those of the city above ground portray a series of seemingly fortuitous encounters connected to the messy vitality of the street, an unpredictable place full of possibilities.
SG: I think one of the decisive aspects that shaped this work was being in a city I didn’t know. I’m very interested in the role of professional photography due to the space it has occupied and continues to occupy in the history of photography; it’s probably inseparable from the aspect we often define as artistic or authorial. Street photography and industrial photography are specific genres of photography, which are featured in this project. I thought that photographs of the construction site could coexist in the same book with photographs showing ordinary, everyday life along Broadway during a few days in October 2023. As you said, the project developed through a series of encounters that I did not organize. I’m not sure they were fortuitous, more like expected or sought: I chose a few places where I stopped and watched. The photographs published in this book are ones that I already knew in part and recreated. At the same time the project is an experiment in emancipation from the rule, moving away from and subsequently and inevitably reapproaching the clichés you mentioned at the beginning, which are part of the history of photography and also of the visual knowledge of each of us. These photographs are a description of an open-ended process of observing the surface of the world, which I deceive myself that I can apply to any situation.
AD: Moving away from photographic categories and motifs should allow us to look at photographs for what they are, for what they show and inevitably document. Your photographs show us ephemeral places, places that will be transformed and others that will disappear. The facades of buildings, shop signs and windows, chasms on construction sites, works in progress, people and the myriad other information contained in these pictures acquire the value of a document of change, even just a few weeks later.
SG: Taking photographs is easy, deciding what to photograph and then how to organize the photographs is more complicated. I started this project without knowing exactly what I would find and without being very familiar with Vancouver or the Broadway Corridor. What I photographed and what we see in this book has probably already irrevocably changed. The photograph can be a document of the transformation of the city. If skilfully executed, it includes and expresses the photographer’s intentions, to see, or imagine (document) the future of a social and built landscape that is changing irreversibly.
AD: The connection between photography and time became extraordinarily clear to me when you showed me a collection of (colour!) photographs by Fred Herzog of the streets of Vancouver in the 1950s and ’60s. In the introduction to the collection, David Campany presents Herzog’s work as the result of “the measured, attentive, and ultimately generous view of a mindful observer”. I recognize the same view in your work, which offers us a further key to understanding your photographs.
SG: Fred Herzog’s work is really beautiful, and should perhaps be included among the classics. I saw it a long time ago, long before I knew I could go to Vancouver. I think it’s associated with a personal urge to document his closeness, his city, aware that rapid transformations were underway that would swiftly change the world around him. I think it’s important to look at the work of others from a future perspective. It allows us to acquire an interest in what a (possible) future might be and to reject nostalgia for things that no longer exist and will not return. Photography’s fantastic equivocal relationship with reality continues.
AD: In the same essay, Campany quotes Jane Jacobs, who describes sidewalk life as “movement and change, and although it is life, not art … we may … liken it to the dance”.2 As I read this passage, I thought back to the work of Babette Mangolte and Trisha Brown, which we’d discussed in a previous conversation, and I recognized the same choreographies and gestural vocabulary in several photographs in this book.
SG: For me, Babette Mangolte’s work, her collaboration with performers like Trisha Brown, and her writings are important for thinking about how we can photograph, describe and document space considering the flat, two-dimensional state of the photograph. It is often the human figure and its movement that guides us in the description of space. Certainly, the presence of any human figure within a photograph strongly determines its interpretation. They’re photographs I wish were capable of taking.
AD: In Vancouver you had the chance to meet Jeff Wall and visit his studio. Wall, who has taken almost all his photographs in and around Vancouver, inherited a generic city from Herzog. Very few of his photographs specifically cite Vancouver as the location. Most depict scenes that could take place in any industrialized city. His studio’s not far from VCC-Clark Station, the first station on the Millennium Line Extension. A stone’s throw from the place that ends the sequence in the book. The inscription at the top of the photograph mentions Édouard Manet.
SG: I always try to take photographs as well as possible, which in spatial terms often means finding a point from which to look at things and, for example, understand how they’re lit. At the same time, I try to get to know those who’ve shaped the visual culture of a particular place. In this case you mentioned Jeff Wall; I think his work has changed the way all of us look at photography, while remaining deeply photographic. Fred Herzog provided a historical perspective to the time I spent in Vancouver. In Vancouver I also met Stephen Waddel, we’ve known each other for a long time. You also mentioned Manet, I like reading about him in Franco Rella’s book Il segreto di Manet3 (I can hear his voice again as I read it). Rella portrays Manet as the initiator of the modern age, an era that does not need to end or fade away; it includes and is the origin of the fragmentary nature of the contemporary world. It offers us a chance to test the contemporaneity of anachronism. I like to think the documentary includes the photographer’s intentions and thus his position in relation to the surface of the world we live in and our future.
1 David Campany (2016), “Of Time and Place: The Photography of Fred Herzog” in David Campany, Jeff Wall and Hans-Michael Koetzlee (eds.), Fred Herzog: Modern Color, Berlin, Hatje Cantz.
2 Jane Jacobs (1961) The Death and Life of Great American Cities, New York City, Random House.
3 Franco Rella (2017) Il Segreto di Manet, Milan, Bompiani.
Una conversazione tra Stefano Graziani e Alessandro Dandini de Sylva
AD: La tua ricerca sui cliché della rappresentazione fotografica, sui motivi che identificano una fotografia come appartenente ad una o ad un’altra categoria e sui limiti di queste definizioni può essere una possibile chiave di lettura del tuo lavoro sul cantiere della Millennium Line Extension a Vancouver. Le immagini che hai realizzato lungo il Broadway Corridor, una delle arterie di transito più trafficate del Canada, sembrano voler sfidare il genere della fotografia industriale sconfinando in quello della fotografia di strada. Sia le vedute del cantiere sotterraneo sia quelle della città in superficie documentano una serie di incontri apparentemente fortuiti che hanno a che fare con la vitalità disordinata della strada, un luogo imprevedibile e pieno di possibilità.
SG: Penso che uno degli aspetti determinanti nel dare forma a questo lavoro è stato trovarsi in una città che non conoscevo. Il ruolo della fotografia professionale mi interessa molto, per lo spazio che ha occupato e continua ad occupare nella storia della fotografia; probabilmente è inseparabile dall’aspetto che spesso definiamo artistico o autoriale. La fotografia di strada e la fotografia industriale sono generi specifici della fotografia ed entrambi sono compresi in questo progetto. Ho pensato potessero coesistere nello stesso libro fotografie del cantiere e fotografie che mostrano la quotidianità e la realtà ordinaria lungo la Broadway durante alcune giornate nell’ottobre del 2023. Come dici, il progetto si è sviluppato attraverso un processo di incontri che non ho organizzato. Non sono sicuro siano stati completamente fortuiti, quanto piuttosto attesi o cercati: ho scelto alcuni luoghi dove fermarmi e rimanere a guardare. Le fotografie pubblicate in questo libro sono fotografie che in parte conoscevo già e che ho rivisto. Al tempo stesso, il progetto è un esperimento di emancipazione dalla regola, di allontanamento e successivo e inevitabile avvicinamento ai cliché che hai citato all’inizio, che fanno parte della storia della fotografia e anche della conoscenza visiva di ognuno di noi. Queste fotografie sono la descrizione di un processo aperto di osservazione della superficie del mondo, un processo che mi illudo di poter applicare a qualsiasi condizione.
AD: Allontanarsi dalle categorie e dai motivi fotografici dovrebbe permetterci di guardare le fotografie per quello che sono, per ciò che mostrano e che inevitabilmente documentano. Le tue fotografie ci mostrano luoghi effimeri, luoghi che cambieranno volto e altri che scompariranno. Le facciate degli edifici, le insegne e le vetrine dei negozi, le voragini del cantiere, i lavori in corso, la gente e le altre innumerevoli informazioni contenute in queste immagini acquisiscono, anche a distanza di poche settimane, il valore di un documento sul cambiamento.
SG: Fotografare è semplice, più complicato è decidere cosa fotografare e successivamente come organizzare le fotografie. Ho iniziato questo progetto senza sapere con precisione cosa avrei trovato e senza conoscere bene Vancouver o il Broadway Corridor. Ciò che ho fotografato e che vediamo in questo libro probabilmente è già irrimediabilmente cambiato. La fotografia può essere un documento della trasformazione della città. Se è ben riuscita include ed esprime le intenzioni del fotografo: vedere o immaginare (documentare) il futuro di un paesaggio sociale e di un paesaggio costruito che stanno irreversibilmente cambiando.
AD: La connessione tra la fotografia e il tempo mi è apparsa con straordinaria chiarezza quando mi hai mostrato una raccolta di fotografie (a colori!) di Fred Herzog delle strade di Vancouver negli anni Cinquanta e Sessanta. Nel testo introduttivo alla raccolta, David Campany presenta il lavoro di Herzog come il risultato dello “sguardo misurato, attento e, in definitiva, generoso di un osservatore consapevole”. Uno sguardo che rivedo nel tuo lavoro e che ci offre un’ulteriore chiave di lettura delle tue fotografie.
SG: Il lavoro di Fred Herzog è bellissimo, forse da annoverare tra i classici. L’avevo visto molto tempo fa, ben prima di sapere che avrei lavorato su Vancouver. Mi sembra legato a una sua personale urgenza di documentare la sua prossimità, la sua città, nella consapevolezza che le rapide trasformazioni in corso avrebbero cambiato velocemente il mondo intorno a lui. Penso sia importante osservare il lavoro degli altri da una prospettiva futura. Ci porta alla conquista di un interesse rivolto a un (possibile) futuro e ad escludere la nostalgia per condizioni che non esistono più e che non torneranno. Continua la fantastica relazione equivoca della fotografia con la realtà.
AD: Nello stesso testo, Campany cita Jane Jacobs, che descrive la vita sul marciapiede come “movimento e cambiamento, e, sebbene sia vita, non arte […] potremmo […] paragonarla alla danza”. Leggendo questo passaggio ho ripensato al lavoro di Babette Mangolte e Trisha Brown, di cui avevamo parlato in una nostra precedente conversazione, e ho ritrovato quelle coreografie e quel vocabolario gestuale in diverse fotografie presenti in questo libro.
SG: Per me il lavoro di Babette Mangolte, la sua collaborazione con performer come Trisha Brown, e i suoi scritti, sono importanti per pensare a come poter fotografare, descrivere e documentare lo spazio considerando la condizione piatta e bidimensionale della fotografia. Spesso sono la figura umana e il suo movimento a guidarci nella descrizione dello spazio. Sicuramente la presenza di qualsiasi figura umana all’interno di una fotografia ne determina fortemente la lettura. Sono fotografie che vorrei essere capace di fare.
AD: A Vancouver hai avuto modo di incontrare Jeff Wall e di visitare il suo studio. Wall, che ha realizzato quasi tutte le sue fotografie a Vancouver e nei suoi dintorni, ha ereditato da Herzog una città generica. Pochissime delle sue fotografie parlano specificatamente di Vancouver. La maggior parte raffigura scene che potrebbero aver luogo in qualsiasi città industrializzata. Il suo studio non è lontano dalla VCC-Clark Station, la prima stazione della Millennium Line Extension, ed è a pochi passi dal luogo che chiude la sequenza del libro. La scritta che campeggia nella parte alta della fotografia tira in ballo Édouard Manet.
SG: Cerco sempre di fotografare nel miglior modo possibile, e ciò spesso significa, in termini spaziali, trovare un punto dal quale guardare le cose e (per esempio) capire come sono illuminate. Al contempo, però, cerco di conoscere chi ha plasmato la cultura visiva di un determinato luogo. In questo caso hai citato Jeff Wall; penso che il suo lavoro abbia cambiato il modo in cui tutti noi guardiamo alla fotografia, rimanendo profondamente fotografico. Fred Herzog ha fornito una prospettiva storica al tempo che ho passato a Vancouver. A Vancouver ho incontrato anche Stephen Waddel – ci conosciamo da molto tempo. Citi anche Manet, mi piace leggere di lui ne Il segreto di Manet di Franco Rella (leggendolo, mi sembra di riascoltare la sua voce). Rella pone Manet come iniziatore della modernità, un’epoca che non sente la necessità di terminare o esaurirsi, include ed è l’origine della frammentarietà del contemporaneo. Ci offre la possibilità di testare la contemporaneità dell’anacronismo. Del documentario mi piace pensare includa le intenzioni del fotografo e quindi la sua posizione di fronte alla superficie del mondo in cui viviamo e al nostro futuro.
1 David Campany, Of Time and Place: The Photography of Fred Herzog, Fred Herzog, David Campany, Hans-Michael Koetzle, Jeff Wall (a cura di), Fred Herzog: Modern Color, Hatje Cantz, Berlin, 2016.
2 Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York City 1961.
3 Franco Rella, Il Segreto di Manet, Bompiani, Milano 2017.
An Essay by Alessandro Dandini de Sylva
Words are perfect to analyze an experience; but to express totalities, we need images.1
The idea of a company photobook dates back to the origins of photography itself. In 1851, only twelve years after the official birth of photography, the medium of photography was presented at The Great Exhibition in London as a symbol of modernity and progress, and in the second half of the nineteenth century numerous companies began to document the state of progress of the major engineering and building projects of that era. The images were collected in volumes that were – and still are – beneficial tools for entrepreneurs, shareholders, suppliers, and, last but not least, photographers.In 1861, the Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée commissioned Édouard-Denis Baldus to produce a book of views along the railway line that stretched from Lyon to Marseille to Toulon. Baldus, drawing from decades-long work on the territory, created one of the finest photography company books in the nineteenth century. In Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée the images of the tracks, the stations, the tunnels, and the viaducts, alternated with the traditional views of the landscape and the examples of historical architecture dealt with themes such as nature and culture, old and new means of transport, history and progress.
With the advent of the twentieth century, the new mass arts – photography and graphics – were given over to the service of both industrial advertising and political propaganda. The age of the machine and of the heroic worker from the 1930s, which saw its apotheosis in the Soviet Union, but also in the work of Albert Renger-Patzsch2 and Emil Otto Hoppé3 in Germany, reached a peak in the United States with the book commissioned from Lewis Hine by the Macmillan Company. In Men at Work4, between images of machine-shops, blast furnaces, railways, and mines, the pictures taken by Hine while the Empire State Building was being built between 1930 and 1931 (just one year after the Wall Street Crash of 1929) symbolically embodied the capitalist brazenness of the modern age.
In those same years in France, while the United States was falling headlong into an economic depression, the demand for electric energy – mainly limited to industry and to the wealthiest families – dropped to the point that the electric companies cut their prices in the attempt to expand to new markets. In 1931, the Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité commissioned from Man Ray, an avant-garde American artist living in Paris, the production of a company book. Électricité5 is still today one of the most fascinating and sought-after photography company books, and it contains a series of pictures in which Man Ray succeeded in making the invisible visible: photomontage, solarization, and photo stills appear as though they were pulsating with energy.
As usual, what is of essential importance is the proper combination of authors – photographers, graphic designers, printers – and patrons – companies and publishers willing not just to use creative talents, but also to give them free rein to experiment. “Building an image – this, therefore, is the basic contradiction”.6 Building, that is, putting together the company’s vision and the photographer’s authoriality, and forming, based on these two elements, an image or rather an imaginary. The involvement of the artists in this process of collecting, controlling, and disseminating knowledge brings out questions about the truth, artistic integrity, and the relationship between representation and context. Cray at Chippewa Falls by Lee Friedlander,7 Inside the House of Hanover by William Eggleston,8 and Limestone by Josef Koudelka9 – to name just a few of the most important company books produced between the late twentieth and early twenty-first centuries – are excellent examples, in which the authority of the photographers is so strong (and the freedom afforded by the patrons so sincere) that every image appears in perfect continuity with their artistic practice.
The photographic campaigns included in this collection – commissioned by Ghella from Fabio Barile, Andrea Botto, Marina Caneve, Alessandro Imbriaco, and Francesco Neri – take their place in this historical tradition, and constitute a series of creative explorations into the building of a tunnel. By combining documentation, portraiture, still life, conceptualism, and abstraction, each volume deals with a different type of building site, distinguished by the particular stages and excavating techniques used. The authors involved seem to have mainly been interested in two aspects: the dimension and the physical nature of the spaces, equipment and building materials, and the construction site as a complex system in continuous development, a living, stratified and multidimensional organism.
Fabio Barile’s work on the railway tunnel that will connect Oslo to Ski juxtaposes the images of intricate artificial systems – caverns and tunnels, partial views of building sites and new urbanizations, components of the excavating machinery and clouds of liquid oxygen – and natural ones – the rock formations and the forests that dot the sequence. A seamless visual flow in which man, who is physically absent, leaves a sign of his presence all the same.
Andrea Botto’s images of the tunnel underneath the Brenner Pass are the summary of a performative action. The explosives expert sets up a long succession of preparatory activities that culminate with an explosion of the front of the excavation. The photographic documentation contains a further sequence of images showing the various attempts, both successes and failures, to record the explosive flash of the detonations, interweaving the tale with the meta-tale.
Marina Caneve’s work on the underground line connecting Athens Airport with the Port of Piraeus can ideally be divided into several chapters. The images are arranged in the book in an intricate forest of themes that can be related to the relationship with the city, contemporary planning, and historical memory. The latter is expressed, in turn, in historical, geological, and industrial archaeology. Views of the city and the building site alternate with archaeological findings, coring, and TBM components, in a visual stratification that is a recurring motif in Caneve’s work.
Francesco Neri’s sequence of pictures of the first underground in Hanoi visually cuts across the city, following the trajectory of the future line. Portraiture here, in addition to representing people, also includes areas of the building site, offices, closed streets, dilapidated buildings, centuries-old trees, and intricate urban views. What emerges is a series of images in which the building site, still at an early phase and therefore visually corresponding to a void, determines an area of conflict and challenge to the chaotic, unexpected, and organic environments of Hanoi.
Alessandro Imbriaco’s pictures of the tunnels running beneath Sydney Harbour seem to come from another planet. The atmosphere they evoke is that of the legend of the frontier and of space exploration: an intricate system of signs and symbols that, painted with colored varnish on the walls of the tunnels, resemble rock paintings in an alien place. Lines, arrows, and geometric figures overlap the automatic forms of the machine’s movement over the rocks and the organic traces left by the rock on the machine.
What keeps these different works together is their potential value as a historical archive. Both the photos from the Ghella archive and the ones commissioned from contemporary artists represent a precious resource because they do not just document the evolution of the planning of infrastructural building typologies, but also trace the direction of the future transformations of the city and the landscape in the twenty-first century.
Moreover, a comparative analysis of the two groups of photographic works allows us to introduce a further key to interpretation: “regardless of the nature of the subject represented, we can easily say that each photograph is an archaeological record, as it always, inevitably, refers to the past.”10 But whereas the photographs from the archives are specifically meant to provide a record, in the recently commissioned works this feature appears to be “incidental”. The new images contain an exceptional number of details, but this seems mainly due to the extraordinary descriptive capacity of the photographic medium. It is a question of language and as such it becomes an object of interest and research for all the authors involved.
Ultimately, this tale through images offers a new and precious cross-pollination between contemporary photography and the corporate world. In times that are so densely populated with images, the artists involved in the project have succeeded in offsetting the fast pace and rhythm of a visual society with the slowing down of the gaze, the obstinate slowness, the stubbornness, the ability to probe scenarios and contexts in depth. This research, which often implies a return to traditional photographic techniques, in a form of archaism, is none other than a way to learn anew and re-educate our ways of seeing.
1 Yona Friedman, L’ordine complicato (Macerata: Quodlibet, 2018).
2 Albert Renger-Patzsch, Kupferhammer Grünthal: Vierhundert Jahre Deutscher Arbeitskultur 1537–1937 (Leipzig: C.G. Röder, 1937).
3 Emil Otto Hoppé, Deutsche Arbeit (Berlin: Verlag Ullstein, 1930).
4 Lewis W. Hine, Men at Work: Photographic Studies of Modern Men and Machines (New York: The Macmillan Company, 1932).
5 Man Ray, Électricité (Paris: La Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité, 1931).
6 Friedman, L’ordine complicato.
7 Lee Friedlander, Cray at Chippewa Falls (Chippewa Falls (WI): Cray Research, 1987).
8 William Eggleston, Inside the House of Hanover (London: Hanover Acceptances Group, 1991).
9 Josef Koudelka, Limestone (Paris: Groupe Lhoist, 2001).
10 Francesco Zanot, A Question of Time, edited by Alessandra Capodiferro, Lavinia Ciuffa, Marco Delogu (Punctum: Roma, 2010).
Un testo di Alessandro Dandini de Sylva
Le parole sono perfette per analizzare un’esperienza; per esprimere le totalità, abbiamo bisogno delle immagini.1
L’idea di un libro fotografico aziendale è vecchia quasi quanto la fotografia stessa. Nel 1851, solo dodici anni dopo la nascita ufficiale della fotografia, il mezzo fotografico fu presentato all’Esposizione Universale di Londra come simbolo di modernità e progresso, e nella seconda metà del XIX secolo numerose aziende iniziarono a documentare lo stato di avanzamento di grandi progetti di ingegneria e costruzioni dell’epoca. Le immagini venivano raccolte in volumi che erano – e restano – strumenti benefici per imprenditori, azionisti, fornitori e, non da ultimo, fotografi.
Nel 1861 la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée incaricò Édouard-Denis Baldus di produrre un libro di vedute lungo la linea ferroviaria da Lione a Marsiglia e Tolone. Baldus, attingendo a un lavoro decennale sul territorio, realizzò uno tra i migliori libri fotografici aziendali del XIX secolo. In Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée le immagini dei binari, delle stazioni, dei tunnel e dei viadotti, alternate con classiche vedute di paesaggio e di architetture storiche – come i bastioni di Avignone, la Maison Carrée e il Pont du Gard – affrontano temi come natura e cultura, vecchi e nuovi metodi di trasporto, storia e progresso.
Con l’avvento del XX secolo, le nuove arti di massa – fotografia e grafica – furono messe al servizio tanto della pubblicità industriale quanto della propaganda politica. L’età della macchina e del lavoratore eroico degli anni Trenta, che vide la sua apoteosi in Unione Sovietica, ma anche nel lavoro di Albert Renger-Patzsch2 ed Emil Otto Hoppé3 in Germania, raggiunse negli Stati Uniti il suo apice con il libro commissionato a Lewis Hine dalla Macmillan Company. In Men at Work,4 tra immagini di officine meccaniche, altiforni, ferrovie e miniere, le fotografie scattate da Hine durante la costruzione dell’Empire State Building tra il 1930 e il 1931 (solo un anno dopo il crollo di Wall Street del 1929) incarnarono simbolicamente la temerarietà capitalista dell’epoca moderna.
In quegli stessi anni in Francia, mentre gli Stati Uniti precipitavano nella depressione, la domanda di energia elettrica – limitata principalmente all’industria e alle famiglie più ricche – scese a tal punto che le aziende elettriche abbassarono le tariffe nel tentativo di espandersi in nuovi mercati. Nel 1931, la Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité decise di commissionare a Man Ray, un artista d’avanguardia americano che viveva a Parigi, la produzione di un libro aziendale. Électricité5 è tutt’oggi uno dei più affascinanti e ricercati libri fotografici aziendali, e contiene una serie di fotografie in cui Man Ray riesce a rendere visibile l’invisibile: fotomontaggi, solarizzazioni e fotogrammi appaiono come se fossero pulsanti di energia.
Come sempre, ciò che risulta fondamentale è la giusta combinazione di autori – fotografi, grafici, tipografi – e committenti – aziende ed editori disposti non solo ad impiegare talenti creativi, ma anche a consentire loro di sperimentare. «Costruire un’immagine – è questa, dunque, la contraddizione di fondo».6 Costruire, cioè mettere insieme la visione dell’azienda e l’autorialità del fotografo, e formare a partire da esse un’immagine o, meglio ancora, un immaginario. Il coinvolgimento degli artisti in questo processo di raccolta, controllo e diffusione di conoscenza fa emergere le questioni della verità, dell’integrità artistica, del rapporto tra rappresentazione e contesto. Cray at Chippewa Falls di Lee Friedlander,7 Inside the House of Hanover di William Eggleston8 e Limestone di Josef Koudelka9 – per citare solo alcuni tra i più rilevanti libri fotografici aziendali realizzati tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo – sono eccellenti esempi in cui è talmente forte l’autorità della visione dei fotografi (e sincera la libertà concessa dai committenti) che ogni immagine appare in perfetta continuità con la loro pratica artistica.
Le campagne fotografiche che formano questa raccolta – commissionate da Ghella a Fabio Barile, Andrea Botto, Marina Caneve, Alessandro Imbriaco e Francesco Neri – si inseriscono in questa storica tradizione e costituiscono una serie di esplorazioni creative della costruzione di un tunnel. Combinando documentazione, ritrattistica, natura morta, concettualismo e astrazione, ogni volume si confronta con un diverso tipo di cantiere, contraddistinto dal particolare stato di avanzamento e dalle tecniche di escavazione impiegate. Gli autori coinvolti sembrano essere stati interessati principalmente a due aspetti: le dimensioni, la struttura e la fisicità degli spazi, dei macchinari e dei materiali da costruzione, e l’infrastruttura come sistema complesso in continuo divenire, un organismo quasi vivente, stratificato e multidimensionale.
Il lavoro di Fabio Barile sul tunnel ferroviario che collegherà Oslo a Ski giustappone le immagini d’intricati sistemi artificiali – caverne e gallerie, scorci di cantiere e nuove urbanizzazioni, componenti di macchine escavatrici e nuvole di ossigeno liquido – e naturali – le formazioni rocciose e i boschi che punteggiano la sequenza. Un flusso visivo senza soluzione di continuità in cui l’uomo, fisicamente assente, lascia comunque tracce della propria presenza.
Le immagini di Andrea Botto della galleria sotto il passo del Brennero si presentano come il resoconto di un’azione performativa. Il fuochino, detto anche brillatore di mine, mette in scena una lunga successione di attività preparatorie che culminano con la spettacolare esplosione del fronte di scavo. La documentazione fotografica contiene al suo interno un’ulteriore sequenza di immagini che mostra i diversi tentativi, sia riusciti che falliti, di registrare il lampo esplosivo delle detonazioni, intrecciando il racconto con il meta-racconto.
Il lavoro di Marina Caneve sulla linea metropolitana che collegherà l’aeroporto di Atene al porto del Pireo può essere idealmente frazionato in più capitoli. Le immagini sono ordite nel libro in un’intricata foresta di temi riconducibili al rapporto tra città, progettazione contemporanea e memoria storica. Quest’ultima si articola a sua volta in archeologia storica, geologica e industriale. Vedute della città e del cantiere si alternano a reperti archeologici, carotaggi e componenti della TBM, in una stratificazione visiva che è ricorrente nella pratica di Caneve.
La sequenza di Francesco Neri della prima metropolitana di Hanoi scavata in sotterraneo taglia visivamente la città, seguendo la traiettoria della futura linea. La pratica del ritratto, oltre alle persone, si apre anche ad aree di cantiere, uffici, strade interrotte, palazzi spezzati, alberi centenari e intricate vedute urbane. Ciò che emerge è una serie di immagini in cui il cantiere, ancora nelle sue fasi iniziali e quindi visivamente rispondente a un vuoto, determina una zona di conflitto e di sfida agli ambienti caotici, imprevisti e organici di Hanoi.
Le fotografie di Alessandro Imbriaco dei tunnel che corrono sotto la baia di Sydney sembrano provenire da un altro pianeta. L’atmosfera che evocano è quella del mito della frontiera e dell’esplorazione spaziale: un intricato sistema di segni e simboli che, dipinti con vernici colorate sulle pareti delle gallerie, appaiono come pitture rupestri in un ambiente alieno. Linee, frecce e figure geometriche si sovrappongono alle forme automatiche del passaggio della macchina sulla roccia e alle tracce organiche lasciate dalla roccia sulla macchina.
Ciò che tiene insieme i diversi lavori è il loro potenziale valore storico. Sia le fotografie provenienti dall’archivio di Ghella sia quelle commissionate ad artisti contemporanei rappresentano una risorsa preziosa perché non solo documentano l’evoluzione storica della progettazione di tipologie di edilizia infrastrutturale nel XX secolo, ma tracciano anche la direzione delle future trasformazioni delle città e del paesaggio nel XXI secolo.
Inoltre, un’osservazione comparata dei due corpi fotografici permette di introdurre un’ulteriore chiave di lettura: «a prescindere dalla natura del soggetto rappresentato, si può dire che ogni fotografia è una testimonianza archeologica, poiché sempre, inevitabilmente, si riferisce al passato.»10 Ma se le fotografie dell’archivio prevedono come proprio scopo specifico la documentazione, diversamente nelle opere recentemente commissionate questo attributo appare come un “accidente”. Le nuove immagini contengono un’eccezionale quantità di dettagli, ma ciò sembra dovuto principalmente alla straordinaria capacità descrittiva del mezzo fotografico. È una questione di linguaggio e in quanto tale diventa oggetto di interesse e di ricerca per tutti gli autori coinvolti.
In definitiva, questo racconto per immagini propone una nuova e preziosa contaminazione tra fotografia contemporanea e mondo dell’impresa. In un’epoca così densamente popolata d’immagini, i cinque artisti inclusi nella raccolta sono riusciti ad opporre ai ritmi serrati della società visiva un rallentamento dello sguardo, una lentezza ostinata, caparbia, capace di scandagliare a fondo scenari e contesti. Questa ricerca, che spesso implica il ritorno alle tecniche fotografiche tradizionali, in una forma di arcaismo, non è altro che un modo per reimparare e rieducare a vedere.
1 Yona Friedman, L’ordine complicato, Quodlibet, Macerata 2018.
2 Albert Renger-Patzsch, Kupferhammer Grünthal: Vierhundert Jahre Deutscher Arbeitskultur 1537–1937, C.G. Röder, Leipzig 1937.
3 Emil Otto Hoppé, Deutsche Arbeit, Verlag Ullstein, Berlin 1930.
4 Lewis W. Hine, Men at Work: Photographic Studies of Modern Men and Machines, The Macmillan Company, New York 1932.
5 Man Ray, Électricité, La Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité, Paris 1931.
6 Friedman, L’ordine complicato cit.
7 Lee Friedlander, Cray at Chippewa Falls, Cray Research, Chippewa Falls (WI) 1987.
8 William Eggleston, Inside the House of Hanover, Hanover Acceptances Group, London 1991.
9 Josef Koudelka, Limestone, Groupe Lhoist, Paris 2001.
10 Francesco Zanot, A Question of Time, a cura di Alessandra Capodiferro, Lavinia Ciuffa, Marco Delogu, Punctum, Roma 2010.
Fabio Barile and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: It was in the introductory essay to a collection of traditional legends from the island of Ischia that I found a definition of geology that I could use to introduce your research: “An incessant and considerable amount of study via the autopsy of cracks and clefts, the breaking up of rocks and the digging of lands, aimed at decoding based on the creases of the earth the modalities of that historical memory that reverberates time in space, unravelling the latter in a deep and stratified reality, a multidimensional one in that it coalesces past and present, continuous and discontinuous, real and imaginary”.1
FB: I like the definition you quote because it sums up in a single sentence concepts that are at the heart of my work. In recent years I have focused on the study of geology and the mechanisms of the formation and transformation of the landscape. The study of geomorphology has allowed me to investigate geological time and the human perception of such a vast temporality. In a previous conversation where the question had emerged about whether or not the subject of my research was the landscape, I remember you telling me that in my work, like in that of other artists in our generation, the landscape had been transformed from the subject of the research into the language of the research. I totally identify with these words. My work on geology is not focused on the observation of specific places, but on the representation of time via the shapes of the landscape. The photography of the landscape thus becomes a philosophical tool with which to examine the natural processes that surpass our imagination, in the attempt to come to terms with a different perception of time. Over the course of my research, I have inevitably come up against themes such as stratification, interconnectivity, multidimensionality, and complexity. The history of geology has forced me to look at the landscape as a dynamic and complex system, to which a simplistic and linear vision cannot be applied.
AD: Your photographic campaign at the Follo Line High-Speed Railway Project in Oslo seems to be positioned midway between your work An Investigation of the Laws Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land, which includes a series of observations of geological phenomena and the simulations of natural processes, and your current research on interconnectivity, in which you explore what Romain Rolland referred to as “oceanic feeling”, meaning the feeling of being at one with the universe.
FB: The photographic approach that emerged in An Investigation, which was then expanded and consolidated in the more recent work, is that of discontinuity. In the case of geology, it was a methodological approach that was circumscribed by a complex yet coherent theme, while in the more recent work it also became an inter-thematic approach facing several themes that relate to each other within this same corpus of work. In my photographic campaign at Follo Line I tried to make this discontinuous vision emerge, in which woods, rock walls, cultivated fields, concrete casts, excavating machines, and various constructions seem to be thematically distant from each other, but are actually part of a single complex system that is constantly evolving. Although there does not seem to be a connection between the images I produced, the truth of the matter is that the distance between those images represents the space of the unknown, the relation- ship between things which escapes us. The contemporary philosopher Timothy Morton, in his essay on hyperprojects, describes them as multidimensional entities that escape our perception, objects of which we can only see fragments (one example of a hyperproject he insists on is global warming, which is manifested in ways that are at times contradictory). My research is focused on this sense of perceptive impossibility before vast entities. Working on the building site of such an imposing infrastructure gave me the chance to apply to something concrete a way of thinking that in my artistic practice remains by choice anchored to several purely philosophical aspects.

Fabio Barile, Untitled, 2017
AD: What emerges is a series of images in which man, who is physically absent, still leaves a sign of his presence. This takes me back to one of the first photographs in history: Boulevard du Temple taken by Louis Daguerre in 1838 in Paris. The image was obtained with an exposure time of about seven minutes. The street and the sidewalks appear to be empty, but it is more likely that they were rather crowded at the time: everything was moving too quickly to be picked up by the plate. At the same time, the absence of human figures in your work would seem to be the direct consequence of managing temporal horizons that go well beyond the time of human existence.
FB: Since the beginning of my artistic path I have found it limiting to thing about photography projects from a purely anthropocentric point of view. This encouraged me to investigate a different temporality, which is that of our planet, in which the human being plays a marginal role. The absence of the human figure in my images aims to undo some certainties that are specifically human, such as the feeling of being a unique and special centre. The “oceanic feeling” that Rolland spoke of represents the conquest or re-conquest of a feeling of belonging to the world and not the other way around, which I see as being the only feasible path. Avoiding the direct presence of humans is of twofold value: to give importance to things in themselves, and to visually restore a feeling of temporal suspension.

Fabio Barile, 1 hour of Venus #2, 2020
AD: The result of this is a visual stratification of intricate natural systems, like the images of woods that dot the sequence, and artificial ones, the caves, tunnels, partial views of the building site and new urbanizations, parts of excavating machines and clouds of liquid oxygen. A seamless visual flow.
FB: I have always avoided thinking about the structures present in nature and the ones built by humans as distinctly separate entities, caged within the labels of “natural” and “artificial”. Where is the border? What’s the difference between a branch used by a bird to pull a worm out of a hole in a trunk, and a particle accelerator? Aren’t they both the outcome of an evolution that at first involved matter, causing stars, planets, and galaxies to evolve; after which the same components were transformed into living beings that over the course of their evolution developed the capacity to imagine a different use for that branch, for that sharp stone, or that metal that could be shaped if heated enough? In a BBC documentary on geology, the geologist Ian Stewart can be seen standing in front of an airplane, describing it as one of the most prodigious technological inventions by humans. But then he invites us to consider the fact that each individual material in that airplane (the aluminium, steel, titanium, rubber for the tyres, and the fuel it needs for take-off) is already present in nature. At the same time, if I look at a forest with branches, leaves, moss, and rocks, or a tunnel with cables, tubes, and modules made of concrete, or the skyline of new buildings being built in Oslo, or at the different parts of the TBM, I see traces of complexity that develop by interweaving the one with the other. I don’t see separation. I see continuous flow instead.
1 Ugo Vuoso, Di fuoco, di mare e d’acque bollenti. Leggende tradizionali dell’isola d’Ischia (Lacco Ameno d’Ischia: Imagaenaria, 2002).
Una conversazione tra Fabio Barile e Alessandro Dandini de Sylva
AD: Nel saggio introduttivo a una raccolta di leggende tradizionali dell’isola d’Ischia, ho trovato una definizione di geologia che potrei usare per introdurre la tua ricerca: «Un’incessante e discreta attività di studio attraverso l’autopsia di crepe e anfratti, lo scasso di rocce e l’escavazione di terreni, per decodificare dalle pieghe della terra le modalità di quella memoria storica che riverbera il tempo nello spazio, dipanando quest’ultimo in una realtà pro- fonda e stratificata, multidimensionale in quanto amalgamante il passato e il presente, il continuo e discontinuo, il reale e l’immaginario.»1
FB: La definizione che citi mi piace molto perché riassume in una frase concetti centrali nel mio lavoro. Negli ultimi anni mi sono concentrato sullo studio della geologia e dei meccanismi di formazione e trasformazione del paesaggio. Lo studio della geomorfologia mi ha permesso di indagare il tempo geologico e la percezione umana di una temporalità così vasta. In una precedente conversazione in cui era emersa la domanda se la mia ricerca avesse come soggetto il paesaggio o meno, ricordo che avevi detto che nel mio lavoro, come in quello di diversi altri artisti della nostra generazione, il paesaggio si era trasformato da soggetto della ricerca in linguaggio della ricerca. Mi riconosco completamente in queste parole. Il mio lavoro sulla geologia non è incentrato sull’osservazione di luoghi specifici, ma sulla rappresentazione del tempo attraverso le forme del paesaggio. La fotografia di paesaggio diviene dunque uno strumento filosofico per indagare processi naturali che superano la nostra immaginazione, nel tentativo di confrontarsi con una diversa percezione del tempo. Nel corso di questa ricerca mi sono imbattuto inevitabilmente in temi come la stratificazione, l’interconnettività, la multidimensionalità e la complessità. La storia della geologia mi ha obbligato a guardare al paesaggio come a un sistema dinamico e complesso, al quale non è possibile applicare una visione semplicistica e lineare.
AD: La tua campagna fotografica al Follo Line High-Speed Railway Project a Oslo sembra posizionarsi a metà strada tra il tuo lavoro An Investigation of the laws observable in the composition, dissolution and restoration of land, che raccoglie una serie di osservazioni di evidenze geologiche e simulazioni di processi naturali, e la tua attuale ricerca sull’interconnettività, in cui esplori ciò che Romain Rolland chiamava «sentimento oceanico», riferendosi alla sensazione di essere tutt’uno con l’universo.
FB: L’approccio fotografico emerso in An investigation, poi ampliato e consolidato nel lavoro più recente, è quello della discontinuità. Nel caso della geologia, era un approccio metodologico circoscritto a un tema complesso ma coerente, mentre nel lavoro più recente è diventato anche un approccio inter-tematico affrontando temi diversi che si relazionano all’interno dello stesso corpo di lavoro. Nella campagna al Follo Line ho cercato di far emergere questa visione discontinua, in cui boschi, pareti di roccia, campi coltivati, gettate di cemento, macchinari di scavo e costruzioni varie sembrano essere tematicamente distanti fra loro, ma in realtà fanno parte di un unico sistema complesso in continuo divenire. Tra le immagini che ho realizzato sembra non esserci alcuna connessione, in realtà la distanza fra quelle immagini rappresenta lo spazio dell’ignoto, la relazione fra le cose che ci sfugge. Il filosofo contemporaneo Timothy Morton, nel suo saggio sugli iperoggetti, li descrive come entità multidimensionali che sfuggono alla nostra percezione, oggetti di cui possiamo vedere solo dei frammenti (un esempio di iperoggetto su cui insiste è il riscaldamento globale, che si manifesta in modi talvolta anche contraddittori). La mia ricerca si concentra su questo senso di impossibilità percettiva nei confronti di vaste entità. Lavorare al cantiere di un’infrastruttura talmente imponente mi ha dato la possibilità di applicare a qualcosa di concreto un modo di pensare che nella mia pratica artistica rimane per scelta ancorato ad aspetti puramente filosofici.

Fabio Barile, Untitled, 2017
AD: Ciò che emerge è una serie di immagini in cui l’uomo, fisicamente assente, lascia comunque tracce della sua presenza. E questo mi riporta a una delle prime fotografie della storia: Boulevard du Temple ripreso da Louis Daguerre nel 1838 a Parigi. L’immagine fu ottenuta con un tempo di esposizione di circa sette minuti. La strada e i marciapiedi appaiono vuoti, ma è probabile che fosse un momento piuttosto trafficato: tutto si stava muovendo troppo velocemente per essere colto dalla lastra. Allo stesso modo, l’assenza di figure umane nel tuo lavoro sembra una diretta conseguenza del tuo confrontarti con orizzonti temporali che vanno ben oltre il tempo dell’esistenza umana.
FB: Sin dagli inizi del mio percorso artistico ho trovato riduttivo pensare ai progetti fotografici in puro stampo antropocentrico. Questo mi ha spinto a indagare una temporalità diversa, che è quella del nostro pianeta, in cui l’essere umano ha un ruolo marginale. L’assenza della figura umana nelle mie immagini mira a scardinare alcune certezze propriamente umane, come la sensazione di essere un centro unico e speciale. Il «sentimento oceanico» di cui parlava Rolland rappresenta la conquista o riconquista di un senso di appartenenza al mondo e non del mondo che vedo come unica via percorribile. Evitare la presenza diretta dell’uomo ha una duplice valenza: dare importanza alle cose in sé e restituire visivamente una sensazione di sospensione temporale.

Fabio Barile, 1 hour of Venus #2, 2020
AD: Il risultato è una stratificazione visiva di intricati sistemi naturali, come le immagini dei boschi che punteggiano la sequenza, e artificiali, come caverne, tunnel, scorci di cantiere e nuove urbanizzazioni, componenti di macchine escavatrici e nuvole di ossigeno liquido. Un flusso visivo senza soluzione di continuità.
FB: Ho sempre evitato di pensare alle strutture presenti in natura e a quelle costruite dall’uomo come entità distinte, recluse nei concetti di «naturale» e di «artificiale». Dov’è il confine? Che differenza c’è fra un ramoscello usato da un uccello per tirar fuori larve da un buco in un tronco e un acceleratore di particelle? Non sono forse entrambi frutto di un’evoluzione che dapprima ha coinvolto la materia, facendo evolvere stelle, pianeti e galassie, dopodiché quegli stessi componenti si sono trasformati in esseri viventi che nel corso della loro evoluzione hanno sviluppato la capacità di immaginare un utilizzo diverso di quel ramoscello, di quella pietra tagliente o di quel metallo che poteva essere plasmato se riscaldato abbastanza? In un documentario sulla geologia della BBC, il geologo Ian Stewart si presenta davanti ad un aereo descrivendolo come una delle prodigiose invenzioni tecnologiche dell’essere umano, ma poi ci invita a pensare che ogni singolo materiale di quell’aereo (l’alluminio, l’acciaio, il titanio, la gomma degli pneumatici e anche il carburante che lo fa decollare) è già presente in natura. Allo stesso modo, se osservo un bosco con rami, foglie, muschio e rocce o un tunnel con cavi, tubi e moduli di cemento, oppure lo skyline dei nuovi edifici in costruzione di Oslo o i diversi componenti della TBM, vedo trame di complessità che si dipanano intrecciandosi l’un l’altra. Non vedo separazione, vedo un flusso continuo.
1 Ugo Vuoso, Di fuoco, di mare e d’acque bollenti. Leggende tradizionali dell’isola d’Ischia, Imagaenaria, Lacco Ameno d’Ischia 2002.
Andrea Botto and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: The title chosen for this conversation comes from afar. It is fragment no. 40 from Empedocles’ Physical Poem: “Many fires burn below the surface”. An open-ended sentence in which we can find and recognize all the ideas that are present in your work on the Brenner Base Tunnel. Empedocles chose Mount Etna for his final experiment. You turned the blasting excavation in a tunnel into a unique series of visual experiments.
AB: You’re right, and it’s a beautiful quote, for which I thank you. The first time we talked about it, you had taken it from the title of a collection of essays by Marcello Carapezza,1 Sicilian chemist, geologist, and volcanologist. Hence, the relationship with Empedocles, philosopher, physician, and scholar of natural phenomena who lived in Sicily in the fifth century BC should come as no surprise. Among the many legends about him we are interested in the one having to do with his death, which took place on Mount Etna, where he had gone to study volcanic phenomena from close up. The historian Diogenes Laërtius recounted how Empedocles threw himself into the crater, convinced that he was immortal, but was betrayed by the volcano that a few days later spewed out one of his bronze sandals. This ancestral desire to control the elements does not just take me back to my work as an artist, but it also reminds me of another news item. It was 1983 and the eruption of Mount Etna provoked a great flow of lava that threatened the town of Nicolosi. The volcanologists Marcello Carapezza and Franco Barberi suggested using explosives to deviate the flow of the lava’s course, and they involved the Swedish mining engineer Lennart Abersten in their plan. On 14 May 1983 an explosion broke the banks and deviated a part of the lava into an artificial canal. This daring intervention, which had never been done before, proved that their insight was good,2 and the method began to be used in other countries as well. My work at the Brenner Base Tunnel bears witness to a series of attempts, the fruit of ideas that have been developed over the years, to achieve an image that had never been seen before, the photograph of a “blast” in the tunnel that technical, logistic, and safety requirements made practically impossible.
AD: The images in the book are the account of a performative action. The shotfirer stages a long sequence of preparatory activities (from the tracing to the loading of the shot to the connecting of the detonator charges), which culminate in the spectacular explosion of the front of the excavation.
AB: The shotfirer/photographer relationship is based on my over ten years of research into the use of explosives. The book KA-BOOM. The Explosion of Landscape3 is conceived as a fictional handbook on blasting theory and practice, in which the close relationship between photography and explosives is analyzed, starting from the chemistry and specifically the nitrate, continuing with the parallel industrial and technological evolution, all the way to the philosophical and conceptual implications with regards to time, to the randomness and irreversibility of a process that once it is triggered cannot be stopped and that brings with it several levels of risk. KA-BOOM taught me that the most significant and interesting part of the work (of the shotfirer and the photographer) is the wait, the time during which the event is prepared, comprising long activities that are often repetitive in which the greatest amount of concentration is required. Each operation becomes relevant because it is needed to achieve the ultimate Acme.4 However, my aim is not at all to tell a story or to document; rather, it is based on the need to express the performative as well as genealogical dimension of my work, even when I am not the subject of the image.
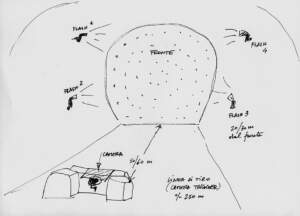
Andrea Botto, illustration showing the position of the shelter for the camera and of the lighting for the crown
AD: The references to the myth of Prometheus are all there: fire is born from the giant, from his body and from his bowels. The natural order and Nature’s equilibrium are thus overturned. The cracks that open up in the Earth’s crust create the communication between the world above and the world below.
AB: When in 1925 the German theorist Siegfried Kracauer visited his friend the architect Gilbert Clavel in Positano, he was astonished and almost terrified. Clavel was building his home by using dynamite to excavate the rock, and using the debris to restructure the Tower of Fornillo ruin. He was digging into the depths to build his truncated pyramid on the outside, he subtracted materials and energy from the bowels of the Earth in order to elevate himself towards the sky and the gods. Clavel’s explosions are the most suitable method to come to terms with chthonic forces, to make a breach in the Earth and to connect the world above ground with the one underground. It is a pendular movement that I found to be a productive model in my journey into the Brenner Base Tunnel as well, where the mountain is excavated and part of the debris returns to the same place in the form of spritzbeton, or in the reinforced concrete models that make up the vault of the railway tunnel.
AD: The documentation of the detonations hides within a further sequence of images that shows the different attempts, both failed and successful, to record the explosive flash that comes from the inside of a gun barrel. The story is interwoven with the meta-story, and the mirror, which appears immediately before and after the fuses are lit, shows us a different subject, which here is not so much the thing that is represented, as much as the person looking at that same thing.
AB: The metaphor of the gun barrel is absolutely spot on with respect to the blasts in the tunnel. When the explosions of the front occurs, the noise is deafening, but what is most impressive is the way the air shifts, moving through the tunnel, trying to find a way out. I wondered how to place the camera close to the front and protect it from the spewing of the materials, and at first I used the expedient of the mirror, a method that is used to record nuclear explosions. Activated at a distance, the camera records the track of the detonating fuse, which serves as a flash in the dark. Through those images we can return again to mythology, or allude to photography’s ability to be both a window and a mirror. Over the course of the years, I have always made the process that leads to the realization of the final work manifest, translating it into a work in itself. However, as I said before, here I wanted to go beyond and try to take a picture (not a video frame) of a blast in a tunnel in the dark. The phases that reveal the defects are perhaps more important than the ones that follow a planned characterization, because they allow for the gradual elaboration of a method. Obviously, I will not reveal all the technical details, but I can say that the experiment was successful thanks to the application to photography of several principles of blasting theory and vice versa.

Andrea Botto, sheet protecting the camera with the signs of the blast debris ejection
AD: Each blast corresponded to a new experiment, a chance to come close to the image that you wanted, each time perfecting the position and the timing of both the camera and the artificial lights anchored to the side walls of the tunnel. Nonetheless, in spite of the numerous attempts made and the different conditions created to check the variables involved, each shot preserved, in its outcome, a certain dose of uncertainty.
AB: There is no doubt an irrational component in trying to control a process that maintains a certain amount of randomness and uncertainty,5 but what upholds the experiment is the design structure and the pre-vision of the final results, which are also typical of photographic thinking. What I am also interested in is the plastic and sculptural potential of the image in expressing the explosion as an ephemeral work on the modification of space. None of this would have been possible without Ghella’s generosity and that of the extraordinary people who satisfied my request, starting from the building of a reinforced concrete shelter for my camera. I think that the results achieved are a cause for satisfaction for them as well.
1 Marcello Carapezza, Molti fuochi ardono sotto il suolo. Di terremoti, vulcani e statue (Palermo: Sellerio, 2017).
2 A detailed report on the matter is available at www.youtube. com/watch?v=Idbd sJOe_nY (last access June 2020).
3 Andrea Botto, KA-BOOM. The Explosion of Landscape (Paris: Bessard, 2017).
4 Acme Corporation is the name of the fictitious company that Wile E. Coyote buys his crazy inventions from.
5 According to Heisenberg’s uncertainty principle, which established the limits of the measurements of a physical system, the very act of the observation modifies the objects observed.
Una conversazione tra Andrea Botto e Alessandro Dandini de Sylva
AD: Il titolo scelto per questa conversazione arriva da lontano. È il frammento 40 del Poema Fisico di Empedocle: «Molti fuochi ardono sotto il suolo». Una frase incompleta in cui possono ritrovarsi e riconoscersi tutte le suggestioni presenti nel tuo lavoro al Brenner Base Tunnel. Empedocle aveva fatto dell’Etna il suo ultimo esperimento. Tu hai fatto dello scavo con esplosivo in galleria un’inedita serie di esperimenti visivi.
AB: Hai ragione ed è una citazione bellissima di cui ti ringrazio. La prima volta che ne abbiamo parlato, l’avevi ripresa dal titolo di una raccolta di saggi di Marcello Carapezza, chimico, geologo e vulcanologo siciliano. Non è un caso quindi la relazione con Empedocle, filosofo, medico e studioso dei fenomeni naturali vissuto in Sicilia nel V secolo a.C. Tra le molte leggende sul suo conto, a noi interessa quella legata alla sua morte, avvenuta sull’Etna dove si era trasferito per studiare da vicino i fenomeni vulcanici. Riferisce lo storico Diogene Laerzio che Empedocle si getta a capofitto nel cratere, convinto della sua immortalità, ma è tradito dal vulcano che pochi giorni dopo erutta uno dei suoi sandali in bronzo. Questo desiderio ancestrale di controllare gli elementi mi riporta non solo al mio lavoro d’artista, ma anche a un altro fatto di cronaca. È il 1983 e un’eruzione dell’Etna provoca una grande colata lavica che minaccia il paese di Nicolosi. I vulcanologi Marcello Carapezza1 e Franco Barberi propongono di deviare il corso della lava usando delle cariche esplosive e coinvolgono l’ingegnere minerario svedese Lennart Abersten. Il 14 maggio 1983 un’esplosione rompe l’argine e devia parte della lava in un canale artificiale. L’ardito intervento, mai tentato prima, dimostra la bontà dell’intuizione,2 e il metodo sarà adottato anche in altri Paesi. Il mio lavoro al Brenner Base Tunnel dà conto di una serie di tentativi, frutto di elaborazioni maturate negli anni, per arrivare a realizzare un’immagine mai fatta prima, la fotografia di una «volata» in galleria, che limitazioni tecniche, logistiche e di sicurezza rendevano praticamente impossibile.
AD: Le immagini nel libro appaiono come il resoconto di un’azione performativa. Il fochino, detto anche brillatore di mine, mette in scena una lunga successione di attività preparatorie (dal tracciamento e caricamento dei fori da mina fino al collegamento delle cariche al detonatore) che culminano con la spettacolare esplosione del fronte di scavo.
AB: Il rapporto fochino/fotografo è alla base della mia ultradecennale ricerca sull’uso degli esplosivi. Il libro KA-BOOM. The Explosion of Landscape3 è concepito come un immaginario manuale di esplosivistica, dove è analizzata la stretta relazione che esiste tra fotografia ed esplosivo, a cominciare dalla chimica attraverso il nitrato, proseguendo con la parallela evoluzione industriale e tecnologica, fino alle implicazioni filosofico-concettuali sul tempo, sulla casualità e sull’irreversibilità di un processo che una volta innescato non può essere fermato e che porta con sé diversi livelli di rischio. KA-BOOM mi ha insegnato che la parte più significativa e interessante del lavoro (del fochino e del fotografo) è l’attesa, quel tempo in cui ci si prepara all’evento, fatto di lunghe attività spesso ripetitive dove è richiesta grande concentrazione. Ogni operazione diventa rilevante perché necessaria al raggiungimento dell’acme4 finale. Il mio però non è assolutamente un intento narrativo o documentario, anzi è piuttosto la necessità di restituire una dimensione performativa oltre che genealogica del mio lavoro, anche quando il soggetto dell’immagine non sono io.
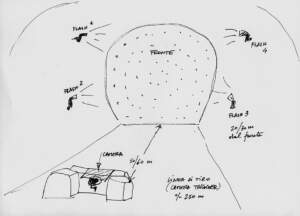
Andrea Botto, schema posizionamento del rifugio per la fotocamera e delle luci sul coronamento
AD: I riferimenti al mito di Prometeo sono presenti: dal gigante, dal suo corpo e dalle sue viscere nasce il fuoco. L’ordine naturale e l’assetto della natura vengono così stravolte, le fenditure che si aprono nella crosta terrestre mettono in comunicazione il mondo superiore con il mondo sotterraneo.
AB: Quando nel 1925 il teorico tedesco Siegfried Kracauer fa visita all’amico architetto Gilbert Clavel a Positano, rimane stupito e quasi terrorizzato. Clavel sta realizzando la sua abitazione scavando la roccia con la dinamite e usando il materiale di risulta per ristrutturare la Torre di Fornillo in rovina. Scava in profondità per costruire all’esterno la sua piramide tronca, sottrae materiali ed energie alle viscere della terra per innalzarsi verso il cielo e gli dei. Le esplosioni di Clavel sono il metodo più adeguato per confrontarsi con le forze ctonie, per squarciare la terra e mettere in comunicazione il mondo superiore con quello sotterraneo. È un movimento pendolare che ho ritrovato come modello produttivo anche nel mio viaggio all’interno del Brenner Base Tunnel, in cui la montagna viene scavata e parte dello smarino ritorna nello stesso luogo sotto forma di spritzbeton o nei moduli di cemento armato assemblati che compongono la volta del tunnel ferroviario.
AD: La documentazione delle detonazioni cela al suo interno un’ulteriore sequenza di immagini che mostra i diversi tentativi, falliti e riusciti, di registrare il lampo esplosivo di una canna di fucile dal suo interno. Il racconto si intreccia con il meta-racconto e lo specchio, che appare immediatamente prima e dopo l’accensione delle cariche, ci mostra un soggetto diverso che qui non è tanto la cosa rappresentata, quanto colui che la guarda.
AB: La metafora della canna del fucile è assolutamente calzante rispetto alle volate in galleria. Quando avviene l’esplosione del fronte, il boato è assordante ma quello che più impressiona è lo spostamento d’aria che risale il tunnel cercando una via d’uscita. Mi sono quindi posto il problema di come piazzare vicino al fronte e proteggere dalle proiezioni di materiali la macchina fotografica, e inizialmente ho usato l’espediente dello specchio, un metodo impiegato per riprendere le esplosioni nucleari. Azionata a distanza, la camera registra la traccia della miccia detonante, che funziona come un lampo nel buio. Attraverso quelle immagini potremmo ritornare di nuovo alla mitologia, oppure alludere alla capacità della fotografia di essere allo stesso tempo finestra e specchio. Nel corso degli anni ho reso sempre più manifesto il processo che porta alla realizzazione dell’opera finale, traducendolo in opera esso stesso. Ma, come ho detto, qui volevo andare oltre e riuscire a fare una fotografia (non un frame da video) di una volata in galleria al buio. Le fasi che rivelano i difetti sono forse più importanti di quelle che seguono una caratterizzazione prevista, perché permettono l’elaborazione progressiva di un metodo. Ovviamente non svelerò tutti i dettagli tecnici, ma posso dire che l’esperimento è riuscito applicando alla fotografia alcuni princìpi di esplosivistica e viceversa.

Andrea Botto, lastra di protezione della fotocamera con i segni delle proiezioni della volata
AD: Ad ogni volata corrispondeva un nuovo esperimento, un’occasione per avvicinarsi all’immagine ambita, perfezionando di volta in volta la posizione e i tempi di scatto sia della macchina fotografica sia delle luci artificiali ancorate sulle pareti laterali della galleria. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi e le diverse condizioni create per controllare tutte le variabili in gioco, ogni scatto ha conservato nel suo esito una certa dose d’incertezza.
AB: C’è sicuramente una componente irrazionale nel voler avere controllo su un processo che mantiene qualche grado di casualità e indeterminazione,5 ma ciò che sorregge l’esperimento è la struttura progettuale e la pre-visione del risultato finale, tipiche anche del pensiero fotografico. Quel che mi interessa sono anche le potenzialità plastiche e scultoree dell’immagine nel restituire l’esplosione come opera effimera di modificazione dello spazio. Il tutto non sarebbe mai stato possibile senza la grande disponibilità di Ghella e delle persone straordinarie che hanno assecondato ogni mia richiesta, a cominciare dalla costruzione di un rifugio in cemento armato per proteggere la macchina fotografica. Penso che i risultati ottenuti siano motivo di soddisfazione anche per loro.
1 Marcello Carapezza, Molti fuochi ardono sotto il suolo. Di terremoti, vulcani e statue, Sellerio, Palermo 2017.
2 Un dettagliato reportage sulla vicenda è disponibile online all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=IdbdsJOe_nY (ultima consultazione giugno 2020).
3 Andrea Botto, KA-BOOM. The Explosion of Landscape, Bessard, Paris 2017.
4 Acme Corporation è il nome della fantomatica ditta da cui acquista le sue strampalate invenzioni Wile E. Coyote.
5 Secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg, che stabilisce i limiti delle misurazioni in un sistema fisico, l’atto stesso dell’osservazione modifica gli oggetti osservati.
Francesco Neri and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: The sequence of images in your book visually reconstructs a line that cuts across Hanoi, following the trajectory of the future underground. Your portraiture, besides depicting people, also opens up to a series of encounters with building site areas, offices, closed streets, devastated buildings, centuries-old trees, and intricate urban views. In any case, the body remains the instrument of perception and measurement.
FN: Finding oneself in the midst of ancient places like Hanoi, and specifically inside building sites that are fully operative and engaged in the construction of works of that size, the confusion between novelty and value, between brutality and force, between appearance and meaning I believe are distinctions and questions that we need to make and ask ourselves. Photography perhaps becomes a way to interpret and transform something that is not easily understood and complex for a mere direct vision, in moments of reflection. As you suggest, the human figure is perhaps at the centre of the effort to offer the “cypher” of space, and, somehow, to permit people looking at the photographs to recognize a similar being in the middle of something that is as far away as it is incomprehensible and perceptively complex. On the other hand, the world of concrete and asphalt is a legacy of the human being, and I believe that separating the work from its author excessively can impoverish that very same work.
AD: Further lines emerge from this series of measurements: momentary interruptions in the urban fabric, such as the metallic divisions between the building site and the surrounding environment, or past separations, such as moss-covered stone walls that protect a garden from the rest of the city. Borders that introduce in your work a pattern of opposites that can be traced back to the relationship between city, infrastructure, and nature.
FN: The more the years go by, from a certain point of view, the more I find myself with less clarity and more doubts with respect to what is happening around me. The questions change and the possible answers follow these evolutionary and physiological processes. There are people who might say that in time they have found answers or greater certainties, but as far as I am concerned, the answers lie simply in asking the question. Photographs are certainly not “answers” and even less so statements, but, on the contrary, they show the uncertainty, precariousness, preoccupation, attempts, changes, or stillness of the contemporary age. This is why I feel comfortable on the edges, on the lines of separation rather than “at the centre”, where it is presumed that the answers are clearer. Michael Crichton, in discussing theories of evolution, defines this borderline sublimely in his novel The Lost World:
Complex systems tend to locate themselves at a place we call ‘the edge of chaos’. We imagine the edge of chaos as a place where there is enough innovation to keep a living system vibrant, and enough stability to keep it from collapsing into anarchy. It is a zone of conflict and upheaval, where the old and the new are constantly at War. Finding the balance point must be a delicate matter – if a living system drifts too close, it risks falling over into incoherence and dissolution; but if the system moves too far away from the edge, it becomes rigid, frozen, totalitarian. Both conditions lead to extinction. Too much change is as destructive as too little. Only at the edge of chaos can complex systems flourish.1

Corso Mazzini, Faenza, 1922. Archivio Fototeca Manfrediana
I like to think that Crichton, in addition to theories of evolution, is also talking about an approach to life: splendidly precarious, which must forever remain uncertain and “vibrant”. I think that photography as well must be looked at in a way that is never definitive, but constantly evolving instead. I am telling you this because in the photographs that were taken in Hanoi, as the first viewer, I see uncertainty, contrasts, and, as you rightly emphasize, I see “ancient separations” between worlds that, in spite of their extreme antithesis, coexist both in a fluid and a tense way.
AD: The idea you suggest of a vibrant equilibrium around the borders also well describes the oscillating movement of the digressions you conducted from the building site. Indeed, although your path was dictated by the trajectory of the new metro line and by the position of the excavations for the new underground stations, you managed to talk about Hanoi in a series of detours from the infrastructure that allowed you to meet with the city and its inhabitants.
FN: The same way that good and bad, hot and cold, light and dark, surface and depth all exist, at the same time I probably felt the need to look at something that was the opposite of the subway building site, looking, yes, at the work being done on the line, but with the echo of what I saw all around it. The same way that at the Louvre we see the Mona Lisa, but we also see the frame, and the wall around the frame, and opposite the wall the hands of the other visitors with their mobile phones in the air as they take pictures of it, and then the floor, the lights that illuminate the room, and so on… simply put, I am as interested in the Mona Lisa as I am in the floor in the room. Bluntly speaking: I think that the floor can reveal the Mona Lisa’s presence in the room even more pungently. Inevitably, a democratic gaze is created, in which every viewer is free to make their own considerations, without drawing hasty conclusions or, even worse, passing judgement.

Francesco Neri, Corso Mazzini, Faenza, 2015
AD: What emerges is a series of images in which the building site, still in its initial phases and thus visually corresponding to a decompression and a void, determines a conflict zone (to use Crichton’s words) and a challenge to the chaotic, unexpected, and organic places of Hanoi.
FN: Yes, I believe it is an interesting thought that adds a further angle of interpretation. The “empty” space created by the building site is not just an intermediate phase. Rather, it, in turn, becomes an important moment that, among other things, will never come back. Paul Graham says that the photographer’s task is to stand in the middle of the river and let the water flow all around them, instead of removing a bucket filled with water as the perfect example of the river itself. In this type of interpretation, photography also and inevitably acquires the status of the document of a unique condition and a moment that is constantly evolving and being renewed. On the other hand, in a way that is also very naive, one of the most exciting aspects of photography is its ability to show us “the way things were!” The photographer, unlike the painter who creates something from nothing, must come to terms with a reality that he or she often finds to be sterile and unsatisfactory. But the passing of time ends up adding a lot to that same photograph that years before we had even found to be tedious. In short, photography (which is considered to be so contemporary) actually requires patience and I think does not lend itself to hastiness. And as you can see, we’re talking about “evolution” again.
AD: Walker Evans said that “art is never a document, though it certainly can adopt that style”.2 Nonetheless, his artistic practice, understood as the democratic accumulation of traces, synthesizes in the photographic image the idea of the archive, and the passing of time entrusts the memory of the camera with the task of witnessing the past.
FN: I think that Walker Evans was absolutely right with regards to art, but I admit that photography, also as a form of art, brings with it an inevitable documentary level that has the ability to “drag” forward in time information that would otherwise be lost. I am fascinated by the meaning and the importance of monumental work such as that of Gardner, Atget, Sander and without a doubt that of Guidi too. In looking at the generous and massive work of these artists I understand the importance of “quantity”. Photographs must exist. Photographs must be taken in order for them to exist. As soon as they exist, whether good or bad, they have the ability to show us something. This something can be an Egyptian pyramid just as it can be the doorframe of an anonymous motel in Oregon. That is not what’s important. The importance of a photograph lies not so much in its subject as in its presence before our eyes. Just like human relationships, where often the best thing is not to resolve other people’s problems, but simply to be there.
1 Michael Crichton, The Lost World (New York: Knopf, 1995).
2 L. Katz, An Interview with Walker Evans, Art in America (March–April 1971).
Una conversazione tra Francesco Neri e Alessandro Dandini de Sylva
AD: La sequenza di immagini nel tuo libro ricostruisce visivamente una linea che taglia la città di Hanoi, seguendo la traiettoria della futura metropolitana sotterranea. La tua pratica del ritratto, oltre che alle persone, si apre anche a una serie di incontri con aree di cantiere, uffici, strade interrotte, palazzi spezzati, alberi centenari e intricate vedute urbane. Lo strumento percettivo e di misurazione resta comunque il corpo.
FN: Trovandosi in mezzo a luoghi antichi come la città di Hanoi e, nello specifico, dentro cantieri pienamente operativi e impegnati nella costruzione di opere di quella portata, credo che sia necessario porsi alcune domande sulla distinzione tra novità e valore, tra brutalità e forza, tra apparenza e significato. La fotografia diventa, forse, un modo per leggere e trasformare in momento di riflessione qualcosa di poco comprensibile e complesso per la mera visione diretta. Come suggerisci tu, la figura umana è forse al centro del lavoro per dare la «cifra» dello spazio e, in qualche modo, per permettere a chi guarda le fotografie di riconoscere un essere affine in mezzo a qualcosa di tanto lontano quanto incomprensibile e percettivamente complesso. D’altronde il mondo del cemento e dell’asfalto è retaggio dell’uomo e credo che separare eccessivamente l’opera dal suo autore possa impoverire l’opera stessa.
AD: Da questa serie di misurazioni emergono anche ulteriori linee: momentanee interruzioni del tessuto urbano, come le divisioni metalliche tra il cantiere e l’ambiente circostante, o antiche separazioni, come le pareti di pietra ricoperte di muschio che proteggono un giardino dal resto della città. Confini che introducono nel tuo lavoro una trama di contrapposizioni riconducibili al rapporto tra città, infrastruttura e natura.
FN: Più passano gli anni e più, sotto un certo punto di vista, mi ritrovo ad avere meno chiarezza e più dubbi rispetto a quello che mi succede attorno. Le domande cambiano e le possibili risposte seguono questi processi evolutivi e fisiologici. Qualcuno potrebbe dire di aver trovato, col tempo, delle risposte o di avere maggiori certezze ma, per quanto mi riguarda, le risposte stanno semplicemente nel porsi la domanda. Le fotografie non sono di certo delle «risposte» o tanto meno delle affermazioni ma, al contrario, mostrano l’incertezza, la precarietà, le preoccupazioni, i tentativi, il cambiamento o l’immobilismo della contemporaneità. Per questo motivo mi sento a mio agio ai margini, sulle linee di separazione piuttosto che «al centro», dove si presume che le risposte siano più chiare. Michael Crichton, parlando delle teorie evoluzionistiche, definisce questa linea di demarcazione in maniera sublime nel suo romanzo Il mondo perduto:
I sistemi complessi tendono a situarsi in un punto che definiremo «il margine del caos». Immaginiamo questo punto come un luogo in cui vi è sufficiente innovazione da dare vitalità a un sistema, e sufficiente stabilità da impedirgli di precipitare nell’anarchia. È una zona di conflitto e di scompiglio, dove il vecchio e il nuovo si scontrano in continuazione. Trovare il punto di equilibrio è una faccenda delicatissima: se un sistema vivente si avvicina troppo al margine, rischia di precipitare nell’incoerenza e nella dissoluzione; ma se si ritrae troppo diventa rigido, immoto, totalitario. Entrambe queste evenienze portano all’estinzione. L’eccessivo cambiamento è letale quanto l’eccessivo immobilismo. I sistemi complessi prosperano solo ai margini del caos.1

Corso Mazzini, Faenza, 1922. Archivio Fototeca Manfrediana
Mi piace pensare che Crichton, oltre che di teorie evoluzionistiche, stia anche parlando di un approccio alla vita: splendidamente precario, che deve restare perennemente incerto e «vibrante». Credo che anche la fotografia debba essere guardata in maniera mai definitiva ma in costante evoluzione. Ti parlo di tutto questo perché nelle fotografie fatte ad Hanoi, come primo spettatore, vedo incertezza, vedo contrasti e, come giustamente sottolinei tu, vedo «antiche separazioni» tra mondi che, nonostante la loro estrema antitesi, coesistono in maniera fluida e allo stesso tempo tesa.
AD: L’idea che proponi di un equilibrio vibrante intorno alle zone di confine descrive bene anche il moto oscillatorio delle divagazioni che hai compiuto dal cantiere. Infatti, nonostante il tuo percorso sia stato dettato dalla traiettoria della nuova linea della metropolitana e dalla posizione degli scavi per le nuove stazioni sotterranee, sei riuscito a parlare di Hanoi attraverso una serie di detour dall’infrastruttura che ti hanno permesso di incontrare la città e i suoi abitanti.
FN: Esattamente come esistono bene e male, caldo e freddo, chiaro e scuro, superficie e profondità, allo stesso modo ho probabilmente sentito il richiamo di guardare un qualcosa in antitesi al cantiere della metropolitana, guardando sì i lavori della linea, ma con l’eco di quello che vedevo tutto attorno. Esattamente come al Louvre vediamo la Gioconda ma, allo stesso tempo, anche la cornice, il muro attorno alla cornice, e davanti al muro le mani di altri visitatori con i cellulari per fare fotografie, e poi il pavimento, le luci che illuminano la sala e cosi via… semplicemente, mi interessa tanto la Gioconda quanto il pavimento della stanza. Per dirla tutta: credo anche che il pavimento possa mostrare in maniera ancora più pungente la presenza della Gioconda nella sala. Inevitabilmente si crea uno sguardo democratico dove ogni spettatore deve essere libero di fare le proprie riflessioni, senza trarre conclusioni affrettate o, ancor peggio, esprimere giudizi.

Francesco Neri, Corso Mazzini, Faenza, 2015
AD: Ciò che emerge è una serie di immagini in cui il cantiere, ancora nelle sue fasi iniziali e quindi visivamente rispondente a una decompressione e a un vuoto, determina una zona di conflitto (per dirla con le parole di Crichton) e di sfida agli ambienti caotici, imprevisti e organici di Hanoi.
FN: Sì, credo sia una riflessione interessante che aggiunge un ulteriore angolo di lettura. Lo spazio «vuoto» creato dal cantiere non è solo una fase intermedia ma diventa a sua volta un momento importante che, per altro, non tornerà mai più. Paul Graham dice che compito del fotografo è stare in piedi in mezzo al fiume lasciando che l’acqua scorra tutto attorno, invece di prelevare un secchio d’acqua come esempio perfetto del fiume stesso. In questo tipo di lettura la fotografia acquisisce anche, e inevitabilmente, lo status di documento di una condizione unica e di un momento in costante evoluzione e rinnovamento. D’altronde, in modo anche molto naïf, uno degli aspetti entusiasmanti della fotografia è la sua capacità di mostrarci «come le cose erano!». Il fotografo, a differenza del pittore che crea dal nulla, deve fare i conti con una realtà che molto spesso trova sterile e insoddisfacente. Ma il tempo che passa fa sì che tanto si aggiunga a quella stessa fotografia che anni prima trovavamo persino noiosa. In parole povere, la fotografia (considerata tanto contemporanea) in realtà richiede pazienza e credo sia poco adatta alla fretta. E dimmi se di nuovo non stiamo parlando di «evoluzione»?
AD: Walker Evans diceva che «l’arte non è mai un documento, anche se può adottarne lo stile».2 Tuttavia, la tua pratica artistica, intesa come accumulo democratico di tracce, sintetizza nell’immagine fotografica l’idea dell’archivio e il passare del tempo affida alla memoria della macchina fotografica il compito di testimoniare il passato.
FN: Credo che Walker Evans avesse pienamente ragione riguardo all’arte, ma ammetto che la fotografia, anche intesa come forma d’arte, porta con sé un inevitabile livello documentario che ha la capacità di «trascinare» avanti nel tempo informazioni che altrimenti andrebbero perse. Sono affascinato dal significato e dall’importanza di opere monumentali come i lavori di Gardner, di Atget, di Sander e senza ombra di dubbio anche il lavoro di Guidi. Guardando l’opera cosi generosa e massiccia di questi autori capisco l’importanza della «quantità». Le fotografie devono esistere. Le fotografie devono essere scattate per esistere. Nel momento in cui esistono, buone o cattive che siano, hanno la capacità di mostrarci qualcosa. Questo qualcosa può di certo essere una piramide egizia tanto quanto lo stipite di una porta di un anonimo motel dell’Oregon. Quello non ha importanza. L’importanza della fotografia non risiede tanto nel suo soggetto quanto nella sua presenza davanti ai nostri occhi. Esattamente come nei rapporti umani, dove molto spesso la cosa migliore non è risolvere problemi altrui ma, semplicemente, esserci.
1 Michael Crichton, Il mondo perduto, Garzanti, Milano 1996.
2 Leslie Katz, Interview with Walker Evans, «Art in America», marzo-aprile 1971, pp. 82–89.
Marina Caneve and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: It is traditional to name mechanical cutters (commonly known as moles or TBM, as in Tunnel Boring Machine) after women. Nonetheless, the mole that dug the section of the Metro 3 in Athens, connecting Haidari, a suburb in the western part of the city, to Piraeus, was given the name Hippodamus, after Hippodamus of Miletus. Hippodamus was one of the first to have theorized not just an urban plan but also an actual master plan, using the earliest practices of zoning. Your work, which can easily be divided up into several chapters or groups of images, seems to be inspired by that practical archaic division of the territory.
MC: Photography and urban planning, at least according to how I have learned to view them, have in common the need for an approach that is, on the one hand, rigorous, and, on the other, curious, exploratory. Hippodamus is considered one of the fathers of modern urban planning, the “inventor” of the grid framework for the city – also used to build the port of Piraeus. Aristoteles uses the name μετεωρολοᾒγος to refer to him, which could be translated scholar of celestial phenomena, or, with a hint of irony, he who gazes at the sky. Precisely because of his eclectic, eccentric, almost mocking biography, Hippodamus was a crucial travel companion in my own work because, on the one hand, he reminded me that I had to go by the rules, yet, on the other, that I was free to break them. Dividing is the same as zoning the elements while delving deep into the relationship between the parts, overturning them in an implacable yet delicate way, to reassemble them in configurations of balance. If we imagine a mosaic, its effect is produced via the deformation of a grid; each stone has its own value, based on its position, shape, colour, but, above all, its individual specificity, which is unique and unrepeatable.1 Though the individual stones share certain features, their position is determined by a more complex design. Furthermore, the fact that the TBM that was used to dig the tunnel that completes the route plan of Athens’ Metro 3 – which connects Eleftherios Venizelos Airport to the Port of Piraeus – bears its name has driven the initial idea of the division, or rather organization, even more to the limit, forcing me to reason, on the one hand, on tech- nological innovations, and, on the other, on the origin of places. A reminder that if the sky is traversed by Apollo’s Chariot, in the sea we have Poseidon.
AD: The pictures you took are arranged in the book in an intricate forest of themes that can be related to the relationship between the city (present), contemporary planning (future), and historical memory (past). In turn, the latter is articulated in historical, geological, and industrial archaeology. Views of the city and the building site are alternated with archaeological finds, core drillings, and TBM parts. A visual stratification that is a common thread in your artistic practice.

Marina Caneve, Ippodamo, Atene, 2020
MC: In the stratifications – and it is especially for this reason that they interest me – the elements contribute to suggesting stories that can shift in space and in time. My work unfolds around a series of fragments. Arranging them is a mnemotechnical operation, where the ability of our intellect lies in the capacity to pay attention to individual things and to their assembly at the same time. Hence, it lies in the ability to discern and to synthesize. If we analyze the relationships between the images and the stratifications of “archaeologies”, I am enthralled by the idea that our relationship with history is a relationship with images that are predetermined and etched in our mind. In today’s age, we find traces of our origins, and manifested in the stratification is the architecture of our imaginary. Besides being similar to that of the urban planner, the photographer’s work is not so different from that of the archaeologist: in both cases it involves finding traces and bringing them to light. Agamben teaches us that archaeology is the search into the past for the possibility of the present, where it itself can be understood as the search for a point of the outset of what is possible, where the column fragments that lie on the ground in flakes go back to being columns.2
AD: Your working method seems to coincide with that of the modern archaeological dig, and more precisely with the stratigraphic dig, whose aim is not limited to the extraction of artefacts from the earth that hides them, but consists in a historical understanding of the human traces hidden in the stratification.

Marina Caneve, Ippodamo, Atene, 2020
MC: When thinking to Athens it is natural to think to archaeology. In archaeological digs we can find a consonance of nature, a contemporary way, and artefacts (often naturalized by the fact that they are in ruins). I wanted to view the building site with this approach, as though I were observing an archaeological dig, analyzing the elements from broad and all-encompassing visions down to the microscopic details. I arrived in Athens at a time in the life of the building site when the traces of the digging of the tunnel were fading. A backwards tunnelling, which I was able to approach right when it was being closed, seeking the signs in the design of the city, in the environment, and in the pre-existing urban fabric. The views are proof of this process. They do not just tell the story of the morphology of a territory characterized by dense urbanization, but they also let us glimpse traces of a complex work process, its healing and disappearing beneath the skin, to become new lifeblood for the city.
AD: In a recent exchange of ideas and references, you spoke to me about the thoughts of Giancarlo De Carlo, Italian architect, urban planner, and academic, who for over thirty years travelled across the Greek archipelago, visiting its monuments and cities. De Carlo believed in complexity, in disorder as order in a complex nature that we cannot decipher. Building an image with a new impressive infrastructure in relation to the city of Athens leads to accepting its complicated order as part and parcel of the work.
MC: De Carlo’s journeys to Greece tell us about “Athens, immense and studded with myths”, but also about Athens being totally balanced amidst the chaos. When you told me I was going to go to Athens I was eager because it is a place whose nature – stratified and chaotic – is very close to my way of thinking, my work, and where, in the disarray, I have the feeling I can find the quiet of the ideal city of Piero della Francesca. In truth, the disarray is a place where lateral narratives overlap, they are like the branches that are grafted onto the main story, information, news, pieces and conjectures overlap.3 The best way to understand a place is to observe the signs left by the architecture in nature. I imagined the tunnel like a tree trunk, with branches that, on the one hand, are the grafts – the shafts, the emergency exits –, on which I chose to stop my gaze because, as is customary for me, I don’t so much seek the spectacular and the magnificent, the direct, as much as I try to look at things from a peaceful and angular perspective. Along with these ramifications, all the digressions possible were manifested, starting from the question of the tunnel. The finding of ancient wells filled with archaeological finds, the problems related to the city’s geology, and, lastly, the components of the TBM that, in turn, become archaeological finds, albeit on a totally different scale, and that tell us of the relationship between the machine and the contemporary city. The lateral vision pushes us towards an agnosticism of thinking. Inspired by the literature by Sebald, the constant rambling produces a hypnotic narrative that ends up representing life and its branches, perhaps more faithfully with respect to documentary reproductions, where each thing happens to satisfy an internal logic and a coherence that is not really realistic. All these very important angular visions allow me to think about how the city takes shape, where the significance and the meaning of the monuments (and by extension of our cities) do not depend on their original destination, but rather it is we, modern subjects, who attribute them.4
1 Yona Friedman, L’ordine complicato. Come costruire un’immagine (Macerata: Quodlibet, 2018).
2 Giancarlo de Carlo, Viaggi in Grecia (Macerata: Quodlibet Abitare, 2010).
3 Ibid.
4 Alois Riegl, Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse, (Paris: Éditions du Seuil 1984).
Una conversazione tra Marina Caneve e Alessandro Dandini de Sylva
AD: È consuetudine battezzare le frese meccaniche (comunemente chiamate «talpe» o TBM, dall’inglese Tunnel Boring Machine) con nomi femminili. Tuttavia alla talpa che ha scavato la sezione della Metro 3 di Atene che collega Haidari, un sobborgo nella parte occidentale della città, al Pireo, è stato dato il nome di Ippodamo da Mileto. Ippodamo è uno dei primi ad aver teorizzato non solo un piano urbano ma anche un vero e proprio piano regolatore, attraverso delle primitive pratiche di zonizzazione. Il tuo lavoro, che può essere idealmente frazionato in più capitoli o gruppi di immagini, sembra essere ispirato a quell’arcaica suddivisione pratica del territorio.
MC: La fotografia e l’urbanistica, per lo meno per come ho imparato a intenderle, hanno in comune la necessità di un atteggiamento da un lato rigoroso e dall’altro curioso, esplorativo. Ippodamo è considerato uno dei padri della moderna urbanistica, «inventore» della struttura a griglia per le città – applicata anche nella costruzione del porto del Pireo. Aristotele lo ricorda con l’appellativo di μετεωρολοᾒγος, che potrebbe essere tradotto con «studioso dei fenomeni celesti» oppure, con un pizzico di ironia, «colui che guarda il cielo». Proprio in ragione di questa sua eclettica, eccentrica, quasi beffarda, biografia, Ippodamo è stato un importante compagno di viaggio nella costruzione del mio lavoro perché mi ricordava che avevo da un lato la necessità di darmi delle regole, dall’altro la libertà di infrangerle. Frazionare equivale a zonizzare gli elementi entrando in profondità nelle relazioni tra le parti, sconvolgendole in modo implacabile ma delicato per poi ricomporle in configurazione di equilibrio. Se immaginiamo un mosaico, il suo effetto si produce attraverso la deformazione di una griglia; «ognuna delle pietruzze ha un proprio valore, dato dalla posizione, dalla sua forma e dal suo colore, ma, soprattutto, dalla sua specificità individuale, unica e irripetibile».1 Ci sono delle caratteristiche che accomunano le singole pietruzze ma è in ragione di un disegno più complesso che ne viene determinata la posizione. Inoltre, il fatto che la TBM con cui è stato scavato il tunnel che completa l’asse viario della Metro 3 di Atene – che collega l’aeroporto Eleftherios Venizelos al Porto del Pireo – porti il suo nome ha spinto ancora più al limite la prima intuizione di suddivisione, o meglio di organizzazione, imponendomi di ragionare da un lato sull’innovazione tecnologica e dall’altro sull’origine dei luoghi, di ricordare che se nel cielo passa il cocchio di Apollo, nel profondo del mare c’è Poseidone.
AD: Le immagini che hai realizzato sono ordite nel libro in un’intricata foresta di temi riconducibili al rapporto tra città (presente), progettazione contemporanea (futuro) e memoria storica (passato). Quest’ultima si articola a sua volta in archeologia storica, geologica e industriale. Vedute della città e del cantiere si alternano a reperti archeologici, carotaggi e componenti della TBM. Una stratificazione visiva che è ricorrente nella tua pratica artistica.

Marina Caneve, Ippodamo, Atene, 2020
MC: Nelle stratificazioni – ed è soprattutto per questo che mi interessano – gli elementi concorrono a suggerire storie che possono spostarsi nello spazio e nel tempo. Il mio lavoro si snoda intorno a una serie di frammenti; ordinarli è un’operazione mnemotecnica, dove l’abilità del nostro intelletto risiede nella capacità di prestare attenzione contemporaneamente alle singole cose e al loro insieme; risiede dunque nella capacità di discernere e in quella di sintetizzare. Se ricerchiamo le relazioni tra le immagini e le stratificazioni di «archeologie», mi affascina l’idea che il nostro rapporto con la storia sia un rapporto con immagini già predefinite e impresse nella nostra mente. Nel contemporaneo noi troviamo le tracce delle nostre origini e nella stratificazione si manifesta l’architettura del nostro immaginario. Oltre a quello dell’urbanista, il lavoro del fotografo non è così diverso da quello dell’archeologo, si tratta di scovare tracce e renderle visibili. Agamben ci insegna che l’archeologia è una ricerca nel passato di una possibilità per il presente, dove essa stessa può essere intesa come ricerca di un punto di insorgenza del possibile, «dove i rocchi che giacciono al suolo sfogliati tornano ad essere colonne».2
AD: Il tuo metodo di lavoro sembra coincidere con quello dello scavo archeologico moderno, e più precisamente con lo scavo stratigrafico, il cui intento non è limitato all’estrazione dei manufatti dalla terra che li nasconde ma consiste nella comprensione storica delle tracce umane celate nella stratificazione.
MC: Pensando ad Atene è naturale pensare all’archeologia; negli scavi archeologici possiamo trovare una consonanza di natura, mondo contemporaneo e artefatti (spesso naturalizzati dal fatto di essere in rovina). Ho voluto osservare il cantiere con questa attitudine, come avrei guardato uno scavo archeologico, analizzandone gli elementi da visioni ampie e complessive fino a dettagli microscopici. Sono arrivata ad Atene in un momento della vita del cantiere in cui si cominciavano a perdere le tracce dello scavo del tunnel. Uno scavo al contrario, al quale mi sono potuta approcciare nel momento in cui veniva chiuso, ricercandone i segni nel disegno della città, nell’ambiente e nel tessuto urbano preesistente. Le vedute sono testimoni di questo processo, non solo raccontano la morfologia di un territorio caratterizzato da una fitta urbanizzazione, ma lasciano anche intravedere le tracce di un processo di lavoro complesso, nel suo rimarginarsi e scomparire sottopelle, per essere nuova linfa per la città.
AD: In un nostro recente scambio di spunti e riferimenti mi hai parlato delle riflessioni di Giancarlo De Carlo, architetto, urbanista e accademico italiano, che per oltre trent’anni ha viaggiato attraverso l’arcipelago greco visitando i suoi monumenti e le sue città. De Carlo credeva nella complessità, nel disordine come ordine di natura complessa che non sappiamo decifrare. Costruire un’immagine di una nuova imponente infrastruttura in relazione alla città di Atene induce ad accettare il suo ordine complicato come parte integrante del lavoro.

Marina Caneve, Ippodamo, Atene, 2020
MC: I viaggi in Grecia di De Carlo ci raccontano «l’Atene immensa e costellata di miti», ma anche l’Atene totalmente equilibrata nel caos. Quando mi avete raccontato che sarei andata ad Atene, ne sono stata immediatamente entusiasta perché è un luogo la cui natura – stratificata e caotica – sento molto vicina al mio modo di pensare, al mio lavoro, e dove, nel disordine, ho la sensazione di poter ritrovare
la quiete della città ideale di Piero della Francesca. Il disordine in realtà è un luogo dove si accavallano narrazioni laterali; esse sono come «i rami che si innestano alla narrazione centrale», dove «si accavallano informazioni, notizie, tessere e congetture».3 Per leggere un luogo la strada migliore è osservare i segni lasciati dall’architettura nella natura. Ho immaginato il tunnel come il tronco di un albero da cui partono i rami, che da un lato sono gli innesti – i pozzi, le uscite di emergenza –, su cui ho scelto di fermare il mio sguardo perché, come sono solita fare, non cerco tanto lo spettacolare e il magnifico, il diretto, ma piuttosto cerco di guardare le cose da una prospettiva pacata ed angolare. Dall’altro lato, insieme a queste ramificazioni si sono manifestate tutte le digressioni possibili a partire dalla questione del tunnel: i ritrovamenti di antichi pozzi colmi di reperti archeologici, le problematiche legate alla geologia della città, ed infine i pezzi della TBM che diventano a loro volta reperti archeologici, pur su scala totalmente differente, e che ci raccontano la relazione tra macchina e città contemporanea. La visione laterale ci spinge verso un agnosticismo del pensiero; ispirata alla letteratura di Sebald, la continua divagazione produce
una narrazione ipnotica che finisce per rappresentare la vita e le sue diramazioni magari con più fedeltà rispetto alla riproduzione documentaria, dove ogni cosa succede per soddisfare una logica interna e una coerenza che non è davvero realistica. Tutte queste visioni angolari, importantissime, mi permettono di ragionare su come la città prende forma, dove «il senso e il significato dei monumenti» (e per estensione delle nostre città) «non dipendono dalla loro destinazione originaria, ma siamo piuttosto noi, soggetti moderni, che li attribuiamo ad essi».4
1 Yona Friedman, L’ordine complicato. Come costruire un’immagine, Quodlibet, Macerata 2018.
2 Giancarlo de Carlo, Viaggi in Grecia, Quodlibet Abitare, Macerata 2010.
3 Ibid.
4 Alois Riegl, Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse, Éditions du Seuil, Paris 1984.
Alessandro Imbriaco and Alessandro Dandini de Sylva in Conversation
AD: The images you took of the caverns and tunnels that run underneath Sydney Harbour resemble another planet. The atmosphere they evoke is that of Ray Bradbury’s Martian Chronicles. The colonization of Mars is still in the early stages and the few terrestrial settlements that exist are entirely devoted to the extraction of minerals from Martian soil. When the outbreak of a war summons Earthlings back to their planet, Mars will once again be abandoned.1
AI: I think that a lot depends on the first visit to the building site of a cavern. It was Victoria Cross Station. We were right in the centre, surrounded by skyscrapers. Access to the building site was covered by a curtain. Until I crossed it I didn’t see the chasm just a few metres away. I felt uncomfortable, I was wearing a mask, earplugs, a helmet, protective goggles, a high-viz jacket, and galoshes. In Australia it was summer and really hot. I climbed down on foot. I found it hard to carry the equipment. My helmet kept moving and my goggles had fogged up on the first of twenty flights of stairs. During the descent there was a lot of noise. I couldn’t see what was happening outside because the stairs were covered with a thick construction tarp. When I finally got to the bottom, the noise had disappeared and there was no one around. I stood on the last step for a few minutes. There was mud on the ground. I stepped on it and then looked at the footprint left by my boot. It’s hard to walk on mud. Between the rubber of the boot and the water squeezed out by the pressure of the foot a void was created. At every step I had to make a small effort to detach my foot from the ground. The walls were all made of live rock, they were red and the signs of oxidation gave them a disturbing hue. It was filled with cables, structures, and equipment so it was hard to understand how it all worked. The impressions of that first morning greatly influenced my work, which in fact describes the building site as though it were a territory on which an alien civilization had developed. In Bradbury’s Martian Chronicles the colonization of the planet is told based on a succession of exploratory missions that land on Mars. It is a novel that contains different stories: a group of explorers arrives on the planet and finds it is deserted, another group comes to terms with the signs left by the previous mission, in another story there is a visit to the houses and temples of a lost civilization. The photographic tale that is told in this book is organized in a similar manner. I took the photographs as though I were moving about in unknown territory, abandoned by an alien civilization, where it is possible to observe the signs left by its disappearance. The marks on the stone, the technology, and the debris correspond to the three phases of development of the building site: the cavern, the tunnel, and the dismantling of the equipment. But as I was taking pictures of these three elements what I had in mind were footprints on the moon and the rocket-launching platforms.

Alessandro Imbriaco, Treptower park, Berlin, 2014 (detail)
AD: The myth of the frontier and space exploration merges with that of the first men and the enigmatic caves that have preserved their traces for thousands of years. A multitude of lines, arrows, circles, squares, and numbers painted with spray paint and colourful varnishes resemble cave paintings in an alien environment. An intricate system of signs and symbols that overlaps the traces of the machines’ passage over the rocks. And the automatic shapes that are typical of the mechanized excavation correspond to the organic traces left by the rocks on the machine.
AI: These are the first images in the book. They describe the rock as it appears to those who are working. Soon the cavern will be occupied by the various services related to the metro. What I photographed was a space in transition. It seemed interesting to me to document these rocks before they disappeared. I photographed them while trying to make the signs of the tunnel boring machines coexist with the colours of the rock, the signs of oxidation left by the passage of water with painted signs indicating the imminent transformation. This series of photographs is reminiscent of the documentation of a cave painting. While I was taking them, I was also thinking about a job that I did a long time ago, inspired by the Nazca Lines or geoglyphs. Because of their huge size, and their mysterious nature, they have often been cited as an example of alien objects on Earth, even though they were actually huge drawings made on the land by humans two thousand years ago. Perhaps the photographs I took of the rocks, more than documenting a mark, reflect on its ambiguity. When removed from the technical and practical context in which they are inserted, the writings on the walls lose their meaning, they become an aesthetic artefact that is functional to the fiction of the photographic tale.
AD: It’s hard to find a place for your photographic campaign at the Sydney Metro City and Southwest in your artistic research overall. In spite of the extreme precision of the details in your depiction of the walls of the tunnels and in the different components of the TBM, it seems that you followed a path of abstraction rather than one of documentation.
AI: For the past few years I have been doing projects that are extremely different from the ones in the past. The teachings, the projects I have participated in, and my research in the historical archives have opened up new perspectives in my research, with different themes and roles. The main change in my way of photographing is that I no longer work to express through photography the space inside which things happen. I am instead much more interested in trying to portray the expressiveness of what I have before me. In any case, I continue to have a methodical approach and to develop projects based on themed series that during the editing phase are assembled according to aesthetic and narrative principles, which is what happened in this job. Series usually focus on one point of view and one subject. Let me offer a few examples to explain myself better. We already talked about the images of the rock walls: the central series in the book was made by travelling down the corridor of the TBM, and then there’s the series of black seas, taken at night on the harbour below which they were building the tunnels. The latter, in particular, came about almost by chance. I wanted to try to photograph the reflections on the water and to produce a sort of starry sky. I don’t think I succeeded, but the images were all the same interesting and they were useful during the editing phase of the book. The individual series of images describe very little about the environment of the excavation and focus mostly on the aesthetic rendering of the material that things are made of. Surfaces and colours prevail over space and shape. The narrative aspect is instead entrusted to the sequence. That is where the spaces take on forms and are recognizable, and that is where the more narrative aspects of the work emerge.

Alessandro Imbriaco, Barangaroo sites, Sydney, 2020
AD: Luigi Ghirri spoke of a “strange and mysterious balance between our interior and the outside world”,2 probably the same balance that keeps together the various groups of work in a sequence. Balance by subtraction that left out many other series, each of which can be another, different story in your Martian chronicles.
AI: For me taking photographs means transforming reality. The balance that Ghirri talks about establishes the boundaries of this transformation, it defines the relationship between what you see in a photograph and the setting where the photograph was taken. I have always, and still do, used medium- and large-format cameras. This type of equipment requires patience, technique, and time during the production phase, with images that are often born first in your head, and then formalized via the tool. With respect to the past I willingly accept what happens to me while I’m taking pictures. The result of this openness to the unpredictable is that many photographs/series remain outside the work. Over the years, these elements have become increasingly significant in my work, both in qualitative and in quantitative terms. But to go back to this book, here too there are series that for reasons related to space and storyline have been excluded: I spent a whole day taking pictures of the cutterhead of a TBM waiting to be dismantled. I photographed from close up the front surfaces of the machine that after months of excavating were worn down by friction and erosion, the side shields on which the excavated rock had remained encrusted, the bases on which the cutterhead was situated. A whole other book could have been written with these images alone, a sort of journey along the surface of this huge piece of machinery.
1 Ray Bradbury, The Martian Chronicles (New York: Harper Voyager, 2008 [1950]).
2 Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia (Macerata: Quodlibet, 2010).
Una conversazione tra Alessandro Imbriaco e Alessandro Dandini de Sylva
AD: Le immagini che hai scattato delle caverne e dei tunnel che corrono sotto la baia di Sydney sembrano di un altro pianeta. L’atmosfera che evocano è quella delle Cronache marziane di Ray Bradbury. La colonizzazione di Marte è ancora nelle sue fasi iniziali e i pochi insediamenti terrestri sono interamente dedicati all’estrazione di minerali dal suolo marziano. Quando lo scoppio di una guerra richiama i terrestri sul proprio pianeta, Marte resta nuovamente abbandonato.1
AI: Penso che molto dipenda dalla prima visita al cantiere di una caverna. Era quella di Victoria Cross. Siamo in pieno centro, in mezzo ai grattacieli. L’accesso al cantiere è coperto da un tendone, fino a che non l’ho attraversato non mi sono accorto della voragine che c’era a qualche metro di distanza. Ero a disagio, indossavo una mascherina, i tappi per le orecchie, un caschetto, occhiali protettivi, una giacca segnaletica e le galosce. In Australia era estate e faceva molto caldo. Sono sceso a piedi. Facevo fatica a portare l’attrezzatura. Il casco si muoveva perché era stretto male, gli occhialini si erano appannati alla prima delle venti rampe di scale. Durante la discesa c’era molto rumore. Non riuscivo a vedere cosa stesse succedendo all’esterno perché le scale erano ricoperte con un tessuto spesso da cantiere. Quando sono arrivato giù, il rumore era scomparso e non c’era nessuno in giro. Sono restato qualche istante sull’ultimo gradino. Sul pavimento c’era del fango. C’ho messo il piede sopra e ho guardato il segno lasciato dallo stivale. Sul fango si cammina a fatica. Fra la gomma dello stivale e l’acqua strizzata fuori dalla pressione del piede si creava un vuoto. A ogni passo dovevo fare un piccolo sforzo per staccare il piede da terra. Le pareti erano tutte di roccia viva, erano rosse e i segni di ossidazione conferivano loro un tono un po’ inquietante. Era pieno
di cavi, strutture e macchine di cui era difficile capire la funzione. Le impressioni di quella prima mattina hanno influenzato molto il mio lavoro, che effettivamente racconta il cantiere come se fosse il territorio su cui si è sviluppata una civiltà aliena. In Cronache marziane di Bradbury la colonizzazione del pianeta viene raccontata dal susseguirsi di missioni di esplorazione che approdano su Marte. È un romanzo composto da diversi racconti: un gruppo di esploratori arriva sul pianeta e lo trova deserto, un altro gruppo si confronta con i segni della missione precedente, un altro ancora visita le case e i templi di una civiltà perduta. Il racconto fotografico di questo libro è organizzato in modo simile. Ho fatto le fotografie come se mi stessi muovendo in un territorio sconosciuto, abbandonato da una civiltà aliena, dove è possibile osservare i segni lasciati da questa scomparsa. I segni sulla pietra, la tecnologia e le macerie corrispondono alle tre fasi di sviluppo del cantiere: la caverna, la galleria e lo smontaggio delle macchine, ma mentre fotografavo questi tre elementi avevo in testa le impronte lunari e le piattaforme di lancio dei razzi.

Alessandro Imbriaco, Treptower park, Berlin, 2014 (particolare)
AD: Il mito della frontiera e dell’esplorazione spaziale si fonde con quello dei primi uomini e delle oscure caverne che hanno conservato le loro tracce per migliaia di anni. Una moltitudine di linee, frecce, cerchi, quadrati e numeri, dipinti con spray e vernici colorate, appaiono come pitture rupestri in un ambiente alieno. Un intricato sistema di segni e simboli che si sovrappone alle tracce del passaggio della macchina sulla roccia. E alle forme automatiche tipiche dello scavo meccanizzato corrispondono le tracce organiche lasciate dalla roccia sulla macchina.
AI: Sono le prime immagini del libro. Raccontano la roccia così come si mostra a chi la sta lavorando. Presto la caverna sarà occupata dai vari servizi della metropolitana. Quello che ho fotografato era uno spazio in transizione. Mi sembrava interessante documentare queste rocce prima che scomparissero. Le ho fotografate cercando di far coesistere i segni delle macchine di scavo con i colori della roccia, i segni di ossidazione lasciati dal passaggio dell’acqua con le scritte di vernice che indicano l’imminente trasformazione. Questa serie di fotografie può ricordare la documentazione di una pittura rupestre. Mentre scattavo, pensavo anche a un lavoro che ho fatto qualche tempo fa, ispirato ai geoglifi di Nazca. A causa delle dimensioni enormi e per via della loro natura misteriosa, sono stati spesso citati come un esempio di reperto alieno sulla Terra, anche se si trattava di disegni enormi realizzati sul terreno dall’uomo duemila anni fa. Le fotografie che ho fatto alle rocce, più che documentare il segno, forse ragionano sulla sua ambiguità. Tirate fuori dal contesto tecnico e pratico in cui sono inserite, le scritte sulle pareti perdono di senso, diventano artefatto estetico funzionale alla fiction del racconto fotografico. La serie si chiude con le fotografie dello scudo di una TBM alla fine del lavoro di scavo. Le immagini sono molto ravvicinate e raccontano l’usura della superficie. Sono le uniche scattate alla luce del sole, i segni sono rovesciati, sono quelli lasciati dalla roccia sulla superficie della macchina che ha concluso il suo lavoro ed è emersa dall’altra parte della galleria.
AD: È difficile posizionare la tua campagna fotografica alla Sydney Metro City and SouthWest all’interno della tua ricerca artistica. Nonostante l’estrema precisione nei dettagli con cui hai ritratto sia le pareti delle gallerie sia i diversi componenti della TBM, sembra che tu abbia seguito più la via dell’astrazione che non quella della documentazione.
AI: Da qualche anno sto facendo lavori estremamente diversi rispetto al passato. L’insegnamento, i progetti partecipati e il confronto con alcuni archivi storici hanno aperto delle prospettive nuove nella mia ricerca, con temi e ruoli differenti. Il cambiamento principale nel mio modo di fotografare è che non lavoro più cercando di restituire attraverso la fotografia lo spazio all’interno del quale accadono le cose, ma sono molto più affascinato dal provare a restituire l’espressività di ciò che ho di fronte. Continuo comunque ad avere un approccio metodico e a sviluppare i progetti attraverso serie tematiche che in fase di editing vengono assemblate seguendo princìpi estetici e narrativi, così come è avvenuto con questo lavoro. Le serie di solito si concentrano su un punto di vista e un soggetto unico. Faccio qualche esempio per farmi capire meglio. Abbiamo già parlato delle immagini delle pareti di roccia, c’è la serie centrale del libro realizzata percorrendo il corridoio della TBM e poi c’è la serie dei mari neri, realizzata di notte sulla baia sotto la quale stanno costruendo le gallerie. Quest’ultima serie, in particolare, è nata un po’ per gioco. Volevo provare a fotografare i riflessi sul mare e produrre una sorta di cielo stellato. Non credo di esserci riuscito ma le immagini erano comunque interessanti e sono state utili in fase di editing del libro. Le singole serie di immagini descrivono molto poco l’ambiente dello scavo e si concentrano più che altro su una restituzione estetica della materia di cui sono fatte le cose; le superfici e i colori hanno la meglio sullo spazio e sulla forma. L’aspetto narrativo è invece affidato alla sequenza: è lì che gli spazi assumono forme riconoscibili ed è lì che emergono gli aspetti più narrativi del lavoro.

Alessandro Imbriaco, Barangaroo sites, Sydney, 2020
AD: Luigi Ghirri parlava di uno «strano e misterioso equilibrio tra il nostro interno e il mondo esterno»,2 probabilmente lo stesso equilibrio che tiene insieme i diversi gruppi di lavori in sequenza. Un equilibrio per sottrazione che ha lasciato fuori diverse altre serie, ognuna delle quali poteva essere un altro diverso racconto delle tue cronache marziane.
AI: Fotografare per me è trasformare la realtà. L’equilibrio di cui parla Ghirri stabilisce i confini di questa trasformazione, definisce il rapporto fra quello che si vede in una fotografia e l’ambiente in cui quella fotografia è stata presa. Ho sempre, e ancora oggi lo faccio, usato macchine di medio e grande formato. È un’attrezzatura che richiede pazienza, tecnica e tempo nella fase di produzione, con le immagini che spesso nascono prima nella testa e poi vengono formalizzate dallo strumento. Rispetto al passato accetto molto più volentieri quello che mi succede mentre sto fotografando. Questa disponibilità all’imprevisto fa sì che molte fotografie/serie restino fuori dal lavoro. Lo scarto è un elemento che negli anni è diventato sempre più significativo nel mio lavoro, sia in termini qualitativi che quantitativi. Ritornando a questo libro, ci sono anche qui delle serie che per questioni di spazio e racconto sono rimaste fuori: ho passato un’intera giornata a fotografare la testa di una TBM in attesa di essere smontata. Ho fotografato da molto vicino le superfici frontali della macchina che dopo mesi di scavo erano consumate dall’attrito e dall’erosione, gli scudi laterali sui quali era rimasta incrostata la roccia scavata, i basamenti su cui era poggiata la testa. Un altro libro poteva essere fatto solo con queste immagini, una sorta di viaggio sulla superficie di questa enorme macchina.
1 Ray Bradbury, Cronache marziane, Mondadori, Milano 2020.
2 Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia, Quodlibet, Macerata 2010.
Fabio Barile, Francesco Neri and Alessandro Dandini de Sylva
Middle-Earth. A journey inside Elica is an exploration of territories from Fabriano – in the Marche, Italy, where the company was born – all the way to Mexico and China. From this journey and from Fabio Barile and Francesco Neri’s projects a variety of landscapes emerge, outlining a research on Elica’s global expansion from the Fabriano valley, enclosed by the Umbria-Marche Apennines, to the historical Querétaro territory in Mexico and the modern industrial landscape of Shengzhou in China.
ADS. Place and identity are two interconnected elements which must be firmly drawn together and aligned in order to be understood. In what terms did your work contribute to the difficult task of defining Elica’s identity in relation to the complexity of its landscape?
FN. This is a difficult question. Every time we talk about abstract relations, such as that between place and identity, we can easily fall into implying ill-concealed hierarchies. I work with photography precisely because, in a way, it prevents this occurrence by placing every subject on the same level. Identity – the idea of home for example – is more a shifting background rather than a fixed concept, a porous backdrop containing information about relations. Consequently, finding myself taking photos so far from my home in Faenza, where I was born, I tried even harder to photograph as if I were still there in order to create the right “temperature” and allow the play of identities to operate in that context, finding a stable balance regardless of my projections. So I worked without the presumption of being exhaustive or complete, which is, I believe, a dangerous legacy of programmatic photography that would like to show the world as it really is. An objective that if not impossible is epistemologically aggressive, for thoroughness is the last aspiration of photography, I think. But obviously the silence of a photo requires a considerable effort on the side of the viewer quietly looking at it. A photographer always tries his best, tries to fail in the best way possible, according to the chaotic but also precise ratio of Becket’s invitation to “fail better”.
ADS. A mapping of places and the creation of an atlas that has its centre in Fabriano. The heart of the entire company production striving for innovation, the strength of the highest tradition of Italian design, the advanced technology and its workshop-style research oriented activity.
FB. The idea behind the work I carried out in Fabriano, Mergo and Serra San Quirico can be summarized with the verb “to make”, understood in the multiple aspects that this action takes on within a multilayered dimension of a large company. What captured my interest is how this “science of making” comes into practice: from the initial spark in the designer’s mind, to the hands of a technical designer, to those of a prototype designer, who creates a prototype that is then passed on to the research centre; here it will be tested and modified and then returned to the technical designer until a final version is defined, and eventually folded, printed, welded, mounted and packed along the different assembly lines. Among these many steps of “the making”, the one that captured me the most was the prototype and research phase, during which the ideas are tested and carefully assessed on working tables scattered with tools and with traces of the effort being made. The workshops are like the laboratory of an alchemist that at the end of a long process will see his intuition come to life.
ADS. You both use large format cameras. What does this choice entail?
FB. The choice of using a large format camera derives from the need to reduce limitations to the minimum and obtain the highest quality image. I would not consider it a philosophy of life, but surely it determines a very specific approach entailing a slow paced and carefully studied image composition. This said, I also appreciate other techniques, such as infrared photography with a camera I borrowed from the Serra San Quirico research department where it is used to photograph the smoke extraction trails.
FN. I come from a school of photography in which many photographers prefer large format. I have always been attracted by the quality of prints from large negatives (8×10 inches) and since the day I started using this camera I have simply stopped using anything else. The size of the negative is part of the research, just like the retina is part of perception, and – returning to the concept of a “constructive failure” – the power of large format fully embodies the ancient drive for the capture of reality and the impossibility of this endeavour. Still today, when I look at original vintage prints by important photographers of the past, such as Watkins, Atget, Sander or Evans I am enthralled by their veiled voluptuousness, by their beauty and optical performance that reveal the drive to capture and create reality, giving place to a well accomplished failure. My work would like to humbly be part of this line of photography, explicitly paying homage to it but also having something new to say (I hope).
This kind of equipment, so large and heavy, forces you to adopt a very unhurried working method, but the positive aspect of this slow paced work is that it also induces you to a higher level of concentration. Besides, I am training myself to learn an easier and faster use of this kind of equipment that by its own nature tends to deliver a more static and formal result. One thing is for sure: when I take portraits, people tend to trust this kind of camera more. Me and the camera capture only what the sitter is willing to give us.
ADS. A kind of photography that can still answer a need for objectivity and foster a new conception of visual testimony. A photographic method capable of putting the photographer in front of reality, drawing him closer to the neutral and non-expressive side of photography that is the basis of documentary.
FN. I will answer you with a story that comes to mind. Not too long ago I was at Guido Guidi’s house. He told me that if I took a photo of a shopping bag hanging from a tree (there was one right in front of us then), every day, for ten years from then, standing in the same position, at the same time, with the same camera, I would never have two photos the same. They would probably be so different from one another (even only in terms of light) that they could inspire contrasting feelings. The repetition of the same photo of the same subject over and over would teach us something, every day. I keep wondering about this alleged “objectivity” attributed to photographs or – even worse – to “a” photograph in particular. At the same time I also ask myself: are those thousands of photographs of that same shopping bag anti-expressive and neutral or shamelessly romantic?
ADS. What interests me in your photos is the relation between subject and space, the relation the objects establish with space. In particular, especially in the photos of the industrial landscape, besides the relation between the object and the context, we can clearly sense the relation between what is inside and outside the shot.
FB. I would say it is a choice determined by instinct. What I do is try to find a balance between the elements inside and outside the shot. There isn’t a specific formula or calculation behind it. It is a kind of choice that has developed in time.
ADS. Another key element of your work is light. How much and in what terms did the different working conditions (such as the contrasted light outdoors and the homogeneous brightness of the neon lights indoors, the low sun light in Mexico and the diffused light of the grey Chinese landscape) influence your work?
FB. Neon light is not an easy light to work with. An outdoor photographer like me might consider it a “bad light”. But I usually work in whatever conditions I find and I entrust the light and its colour with a crucial role in the outcome of a project. In the shots I took inside the plants I worked with the bluish-grey glow of the neon coming from the high ceilings which created a flat and homogeneous light. Even the outdoor light in Fabriano in fact was dominated by grey, except for some moments. This kind of light looks “exotic” to me for I am not used to it, but I think it delivered some interesting results.
FN. Even if sometimes I would like to, I can never wait for the right light to appear. I often finish my film in the middle of the day. What I think is interesting is to be unfaithful to your own resolutions and end up discovering, once the plates are developed and printed, that you did well not to wait for any moment that might have been “ideally” better. Any moment is the best moment. Sometimes it is the compulsive side of the photographer’s work (like the stamp collector) that prevails over silly stylistic rules. That is when photography shows its extraordinary “unexpected” aspect.
The photographs by the two artists offer an accurate and non-rhetorical portrait of the faces and the places that form Elica’s identity, and they already hold a priceless historical value due to the extraordinarily fast changes affecting industrial landscape. At the same time, the project has the objective of re-establishing a connection between documentary photography and experimental photography, offering an important occasion to keep on exploring the figurative and conceptual dimension of Italian contemporary photography.
Fabio Barile, Francesco Neri e Alessandro Dandini de Sylva
Middle-Earth. A journey inside Elica avvia l’esplorazione di territori collocati lungo un asse geografico che da Fabriano – luogo di nascita dell’azienda marchigiana – si estende fino al Messico e alla Cina. Da questo viaggio e dai progetti sviluppati da Fabio Barile e Francesco Neri emergono diversi paesaggi che costituiscono il periodo inaugurale di una ricerca sulla geografia globale di Elica: la vallata di Fabriano circondata dai monti dell’Appennino umbro-marchigiano, il territorio storico di Querétaro, in Messico, e il moderno paesaggio industriale di Shengzhou, in Cina.